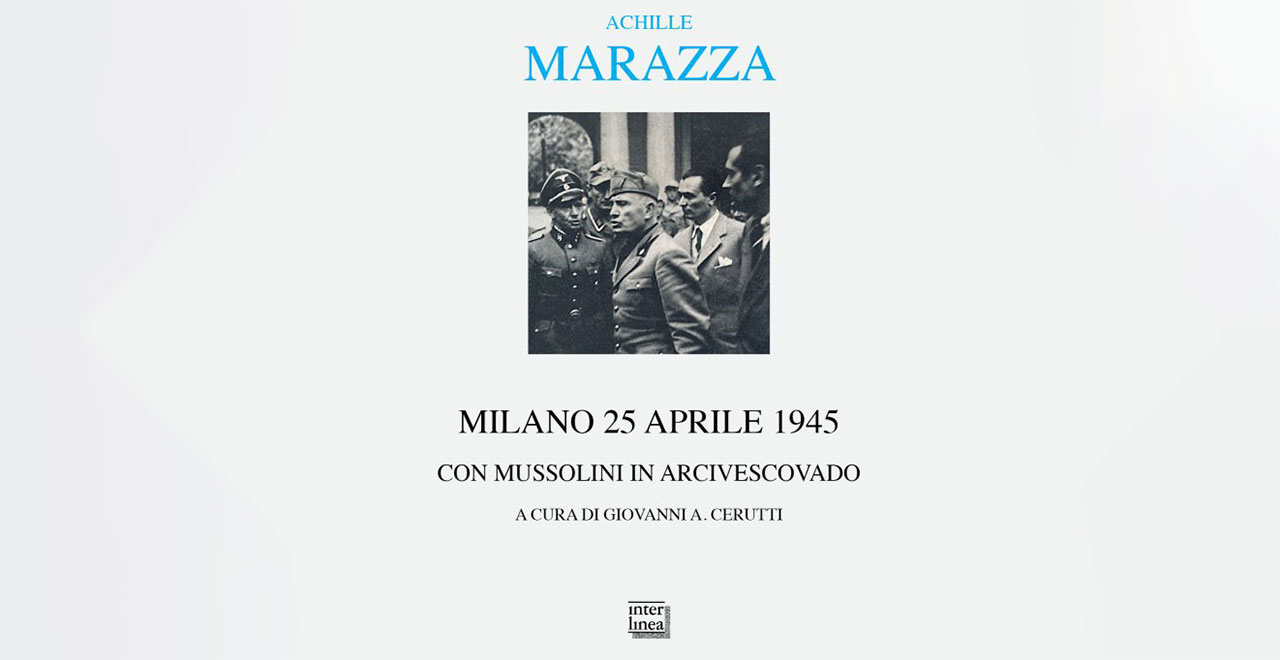Uomo di fiducia di Alcide De Gasperi, nel Dopoguerra sottosegretario e poi anche ministro nei primi esecutivi presieduti dal leader democristiano, Achille Marazza (1894-1967) ebbe un ruolo cruciale negli ultimi giorni di vita di Benito Mussolini. Su incarico del Comitato di Liberazione Nazionale dell’Alta Italia, fu lui a trattare con il dittatore e capo del fascismo nel tentativo di ottenerne la resa. Come è noto, il colloquio voluto dal cardinale Ildefonso Schuster si tenne a Milano in Arcivescovado, ma non portò a nulla: Mussolini alla fine decise di non consegnarsi e di cercare riparo in Svizzera, andando così incontro al proprio destino. Di quelle ore drammatiche Marazza (che dal 1949 al 1954 sedette anche nel Consiglio d’amministrazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore) ha lasciato un dettagliato resoconto, ora edito da Interlinea a cura di Giovanni Cerruti, direttore della Fondazione Marazza di Borgomanero, con il titolo "Milano 25 aprile 1945. Con Mussolini in Arcivescovado". Per gentile concessione dell’editore ne pubblichiamo un ampio stralcio.
Ci sedemmo intorno al tavolo ovale, sul quale stava il bicchierino pieno a metà e un piattino di biscotti, i conforti del cardinale a quel Totila moderno. Di fronte a noi era un uomo vecchio, dalla larga faccia smagrita e cascante, di un giallo malsano, solcata da pieghe, gli occhi sbarrati privi di espressione, e tuttavia, su quella faccia, passava a tratti come un’ombra oscura, come d’un moto d’ira subito contenuto, che lasciava il posto al sorriso forzato di chi vuol conciliarsi un interlocutore difficile. Vestiva un’uniforme spiegazzata, con stivali polverosi e sformati; ma era un’uniforme da caporale d’onore della Milizia, anche quella un segno di potere, sotto un velo di decadenza. Dopo di noi – invitato da Mussolini – era entrato anche Graziani, e, mentre egli richiudeva la porta, vi si erano infilati, forzandola un poco, Zerbino e Barracu. Ora sedevano silenziosi, Graziani alla sinistra del cardinale, Barracu alla mia sinistra, Zerbino fra loro; alla mia destra sedevano Cadorna e Lombardi.
Seguì un momento di pesante silenzio, poi Mussolini si volse a Cadorna, quasi ad avviare il discorso con lui, ma Cadorna, con un gesto largo della mano, indicò me: a me, come rappresentante politico, il Clnai aveva dato l’incarico delle trattative. La grossa testa calva mi si rivolse, e venne la domanda, banale, quasi futile: «E così, avvocato, che cosa ha da dirmi?», come se si trattasse di esporgli qualche mio caso personale, come se fosse stato il Clnai a chiedere quell’incontro. Per un attimo rimasi silenzioso, scegliendo dentro di me la risposta: forse sarebbe stato il momento delle frasi storiche, delle condanne senz’appello: quell’uomo che cercava di forzarci a una cordialità complice, quel vecchio disfatto che in fondo muoveva a pietà, era l’uomo che aveva trascinato il Paese alla guerra e alla sconfitta, l’uomo che ne aveva distrutto le libere istituzioni, per fatale ignoranza delle grandi forze che muovono la storia, per meschine furberie di negoziatori disonesti, che del suo capriccio e della sua presunzione aveva fatto legge, l’uomo che per 20 anni, con il suo Tribunale speciale, aveva distribuito secoli di carcere e di confino, l’uomo che da ultimo, per vile amore della vita e delle apparenze del potere, si era prestato alla farsa sanguinosa della Repubblica di Salò, si era prestato a dare una parvenza di legittimità alle persecuzioni naziste….
…Tutti questi pensieri e altri ancora si affollavano nella mia mente, e la risposta mi uscì dura nella sostanza e temperata nella forma da una pietà senza rispetto. «Le istruzioni che ho ricevuto – dissi – sono rigorose, e non ho altro da chiederle se non di arrendersi senza condizioni». Vidi la grossa faccia davanti a me sollevarsi e contrarsi per un momento, quasi per un moto riflesso, un ritorno inconscio alla consueta burbanza, poi le parole vennero frammentarie: «Non è per questo che io sono venuto qui… allora mi hanno ingannato… io desideravo parlare di ben altro… io sono venuto perché mi avevano detto…» e qui si fermò di nuovo. «Che cosa le avevano detto?» incalzammo. «… mi era stato detto che avremmo discusso della sorte dei gerarchi, che la Milizia avrebbe potuto concentrarsi in Valtellina… il prefetto Bassi sa queste cose, chiamiamo Bassi».
Nel frattempo io soppesavo dentro di me le sue frasi rotte: quell’interesse per i gerarchi mi sembrava più ostentato che reale; forse parlando delle famiglie dei gerarchi egli in realtà pensava alla sua e a se stesso. Anche quella storia del concentramento delle milizie in Valtellina… Ma poi dove erano queste milizie? Se c’erano, non si sarebbero sciolte da sé dopo la resa di Mussolini? Intanto, ciò che importava era ridurre le perdite umane nell’ora ormai prossima dell’insurrezione e la resa di Mussolini poteva disarmare molti, ingenui, o fanatici o paurosi. Se poi le milizie c’erano, si ritrovassero pure in Valtellina, se ne sarebbe parlato dopo, quando Milano fosse libera e salva: una cosa per volta.
Di nuovo, tutti questi pensieri passarono in me rapidissimi. Dissi: «Questi sono particolari della resa, di questo si può trattare». Sentii la voce di Riccardo Lombardi farmi eco, anche lui aveva fatto i suoi conti. La grossa faccia si distese di nuovo, quasi si aprì a un sorriso accomodante: «Allora possiamo continuare la discussione», e, in un’atmosfera fattasi per un momento meno tesa, Mussolini parlò dei gerarchi, per i quali chiedeva l’immunità in cambio della resa, chiedeva che potessero ritirarsi a Varese con le famiglie. Vicino a me Riccardo Lombardi ruppe di nuovo il silenzio e annunciò con voce pacata: «I responsabili saranno giudicati». Mussolini non chiese spiegazioni, anzi parve non raccogliere; aveva fretta di andare avanti, forse di arrivare al nodo del suo destino e di quello della sua famiglia e dell’amante. Passammo a parlare della ritirata delle milizie in Valtellina. «Come saremo garantiti – chiesi – che non provocheranno scontri con i partigiani che occupano la valle?» Rispose con una breve esclamazione scettica e con un gesto della mano, come a dire chiaramente che non c’era pericolo, che quelle milizie non avevano nessuna voglia di battersi. Era quel che pensavo anch’io, anche se non sapevo in quel momento la storia tragicomica del ridotto in Valtellina, non sapevo che pochi giorni prima, alla villa Feltrinelli, Pavolini aveva dichiarato ai tedeschi che le Brigate nere vi si sarebbero concentrate a scrivere «l’epopea dei 50 mila», ma che, quel giorno stesso, Mussolini aveva dichiarato al cardinale di volersi ritirare in Valtellina con una schiera di tremila Camicie nere, e non proprio per scrivere epopee, ma per arrendersi agli Alleati. A ogni modo, anche quell’argomento sarebbe stato facilmente sistemato, e noi sapremmo ora che cosa sperava da noi veramente Mussolini, se in quel momento non fosse scoppiato un incidente che deviò il colloquio e mutò definitivamente il corso degli avvenimenti.
D’improvviso, alla sinistra del cardinale, scattò Graziani. In piedi, eretto, come in posa, incominciò a parlare, e io ebbi la singolare sensazione che recitasse una parte: non era un generale, era un attore che faceva il generale; in realtà, quello era il tono che 20 anni di retorica fascista avevano reso abituale. «Mio duce – stava dicendo – noi abbiamo preso le armi per difendere l’onore e la lealtà dell’Italia nei confronti dell’alleato germanico. Io, ministro della Guerra e comandante supremo delle forze armate della Repubblica sociale, chiedo che il comando germanico venga informato delle nostre trattative!» Aggiunse che ne andava dell’onore e della lealtà dell’Italia: «I motivi – proclamò – che sono all’origine della Repubblica sociale», e aggiunse inaspettatamente, dopo una breve pausa: «Così almeno abbiamo creduto».
Ora io non provavo più neanche pietà: quella sortita, quei richiami all’onore (quale onore!), quel tono, avevano sollevato dentro di me antichi sentimenti di sdegno e di disprezzo, sospesi fino allora dall’aspetto di quegli sconfitti. Non badai a quella riserva finale; dissi, senza trattenere il sarcasmo: «Forse il governo della Repubblica sociale non sa che i tedeschi stanno trattando la resa con noi da sette giorni». A questo punto, come in certe scene di melodramma, l’azione si divise e proseguì in due azioni parallele, mentre sul fondo si agitava il coro (giacché nel frattempo erano entrati anche il prefetto Bassi e don Bicchierai, e il nostro Arpesani, e la stanza era ormai affollata). Graziani, all’improvviso come s’era alzato, ricadde a sedere, e, dopo un momento di silenzio, volgendosi al cardinale, riprese con lui a voce più bassa un discorso concitato.
Mussolini, invece, che aveva ascoltato come infastidito la tirata di Graziani, ora ebbe uno scatto: «Come! – esclamò – Non capisco! I tedeschi stanno trattando con voi?» Risposi: «Siamo in attesa dell’atto di resa, e il termine sta per scadere». La grossa testa si volse verso il cardinale, che confermò pienamente: sì, il generale Wolff stava trattando per suo tramite con il Clnai; il console generale germanico a Milano e il colonnello Rauff erano incaricati delle trattative; le modalità erano già stabilite: i comandanti tedeschi avrebbero firmato la resa nelle mani dell’arcivescovo, per non riconoscere almeno formalmente l’autorità del governo della Resistenza; i soldati si sarebbero ritirati nelle caserme fino all’arrivo degli Alleati. Mussolini era sconvolto; con quell’assoluta mancanza di logica e di autocritica che noi avevamo imparato a conoscere nei 20 anni di dittatura, egli, che si preparava un momento prima a firmare la resa all’insaputa dei tedeschi, ora ardeva di sdegno contro i tedeschi, che si comportavano come lui: «Ci hanno sempre trattati come servi e alla fine ci hanno traditi!» Poi esplose in una lunga invettiva, un elenco di torti e di umiliazioni subite, di promesse non mantenute, di danni patiti.
Ma io non lo ascoltavo più! Accanto al cardinale, Graziani non taceva, anzi si appassionava di nuovo; coglievo frasi staccate e ancora l’onore, la lealtà, i princìpi per i quali molti soldati erano caduti e ai quali egli, Graziani, non voleva trasgredire. Di nuovo cresceva in me l’ira: di quali princìpi blaterava l’uomo che aveva arruolato per forza migliaia di giovani da sacrificare al Moloch nazista! Per di più udii il cardinale ripetergli, come per calmarlo: «Sentimenti nobilissimi… sentimenti nobilissimi». Intervenni: «Vostra Eminenza sa che è per difendere tali princìpi e ideali che noi siamo scesi in campo dalla parte opposta». Graziani mi guardò, tacque un momento, poi disse più piano: «È per questo che poco fa ho detto: così almeno noi abbiamo creduto».
La mia ira si spense: che serviva discutere con quei fantasmi? Le loro responsabilità erano enormi; ma essi non le vedevano, o si giustificavano davanti a loro stessi, o si concedevano il lusso di tardivi ripensamenti. L’Italia, intanto, era colma di morti e di rovine, e gli eserciti alleati avanzavano nella pianura padana, e le truppe tedesche erano dappertutto stanche e sfiduciate, ma ancora armate, e il destino di Milano era in sospeso. Mi volsi verso Mussolini che, esaurito il suo sfogo, si era alzato in piedi, e, rivolto a tutti noi, declamò: «Fin da questo momento dichiaro di riprendere, nei confronti della Germania, la mia libertà d’azione». Ci sarebbe stato da ridere: quale libertà e quale azione? E si poteva aggiungere: quale Germania? Ma Mussolini consultò l’orologio e aggiunse: «Sono le sette e un quarto. Voglio dire ai tedeschi il fatto loro. Fra un’ora sarò di ritorno». Prese sul tavolino la storia di San Benedetto, che il cardinale gli aveva offerto, mi tese ancora una volta la mano, che sfiorai, e si mosse, seguito dai suoi. Tutto ciò non era affatto logico. Mi chiesi se fosse un espediente per troncare le trattative o rinviare la resa, ma anche questo non aveva senso; o forse voleva cercare di inserirsi nelle nostre trattative con i tedeschi e di ottenere ancora la loro protezione per sé e per i suoi, o forse era stato sopraffatto dalla compassione di se stesso e voleva davvero andare a rinfacciare ai camerati tedeschi d’averlo abbandonato…