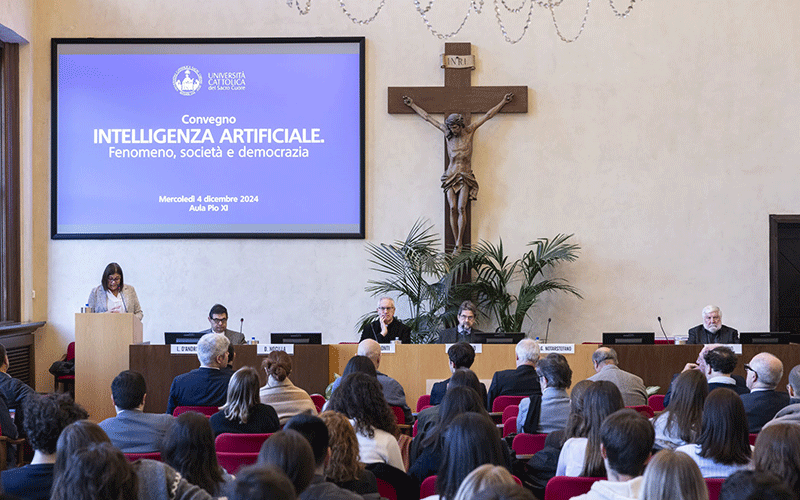La sfiducia epistemica (la tendenza a percepire le fonti di informazione umane come inaffidabili o malevole) è associata ad atteggiamenti più critici verso l’intelligenza artificiale (AI). Le persone che manifestano questa forma di sfiducia tendono a concentrarsi maggiormente sui rischi e sugli svantaggi dell’AI, considerandola con sospetto e quale fonte di potenziale inganno.
Questo è in sintesi quanto emerge da un recente studio condotto dal Centro di Ricerca sulla Teoria della Mente e sulla Competenza Sociale nel Ciclo di Vita (CeRiToM) del campus di Milano dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, con la guida di Antonella Marchetti e la collaborazione di Davide Massaro, Cinzia Di Dio, Federico Manzi e Federica Sacco.
La ricerca, realizzata con Astrid Schepman e Paul Rodway dell’Università di Chester – ideatori della scala GAAIS – si affianca alla validazione italiana della “General Attitudes towards Artificial Intelligence Scale”.
Come percepiamo l’AI che entra sempre più nella nostra quotidianità, cosa suscita fiducia o diffidenza nei suoi confronti e quali meccanismi psicologici influenzano l’accettazione di queste tecnologie?
Lo studio, pre-registrato nel 2024, che affronta queste tematiche ha coinvolto un campione di 121 adulti italiani (61 uomini e 60 donne), con un’età media di 36,57 anni (range 18-65), provenienti da diverse fasce di istruzione e occupazione e ha esplorato in profondità il ruolo della fiducia – e della sfiducia – nei confronti delle fonti di conoscenza, umane e artificiali.
Per fornire un quadro completo dei fattori che influenzano l’atteggiamento verso l’AI e la loro relazione con la fiducia, i partecipanti sono stati valutati anche per il loro livello di conoscenza dell’AI e la loro competenza nell’uso del computer.
Le evidenze emerse, come si accennava all’inizio, mostrano come chi manifesta sfiducia epistemica tende a concentrarsi maggiormente sui limiti dell’AI e che maggiore è la familiarità con l’AI, maggiore è l’apertura nei suoi confronti.
Questo risultato si allinea con la tendenza osservata nello studio per cui, indipendentemente dall’età o dal livello di istruzione generale, gli uomini manifestano minori preoccupazioni o scetticismo riguardo all’AI rispetto alle donne. Per comprendere tale dato, da un lato è plausibile fare riferimento a diversi percorsi di esposizione e interazione con la tecnologia: il genere maschile, infatti, è spesso maggiormente coinvolto in contesti legati allo sviluppo e all’applicazione tecnica dell’AI. Tale maggiore esposizione, ampiamente documentata dalla letteratura sul gender gap nelle discipline stem e nella percezione del rischio tecnologico, si traduce in una familiarità che mitiga la percezione del rischio da parte degli uomini. D’altro canto, la maggiore propensione delle donne a manifestare preoccupazioni o scetticismo verso l’AI può riflettere una particolare sensibilità alle implicazioni sociali ed etiche delle nuove tecnologie. Ciò evidenzia una tendenza a valutare l’AI non solo per le sue capacità funzionali, ma anche per il suo impatto a lungo termine sulla società e sulle relazioni umane.
Inoltre è possibile ipotizzare l’esistenza di strutture psicologiche sottostanti (come vissuti legati a esperienze affidabili o meno, o tratti di personalità) che ci rendono persone tendenzialmente fiduciose o sfiduciate verso gli altri, e di conseguenza anche verso l’AI. La fiducia, in particolare quella epistemica, è trasversale alla fonte informativa, sia essa umana o tecnologica. E se la fiducia generale è il collante delle relazioni sociali, quella epistemica è la base dell’elaborazione dell’informazione e del credito che si dà a ciò che si apprende.
Dal punto di vista psicologico, emerge l’importanza di sviluppare la consapevolezza epistemica, ossia la capacità di valutare criticamente le informazioni, di riflettere su come formiamo le nostre convinzioni e di tollerare l’incertezza. Sul piano educativo, ciò si traduce nella necessità di una alfabetizzazione globale relativa all’AI: conoscere la tecnologia non solo la rende meno spaventosa, ma permette anche di considerarne potenzialità e limiti con maggiore lucidità e promuove una consapevolezza epistemica più inclusiva di tutte le fasce della popolazione. Tuttavia, occorre anche promuovere un’educazione che stimoli la riflessione etica e la responsabilità sociale, al fine di formare cittadini capaci di orientarsi nel complesso ecosistema informativo contemporaneo.
In un mondo in cui le fake news possono essere generate da intelligenze artificiali ma trovano forza nella credibilità (o nella sfiducia) verso chi le diffonde, diventa dunque evidente quanto le dimensioni umana e tecnologica siano intrecciate. Il futuro dell’AI non dipenderà solo dai progressi ingegneristici, ma dalla nostra capacità collettiva di sviluppare una fiducia riflessiva, consapevole e fondata su conoscenza, trasparenza e responsabilità.