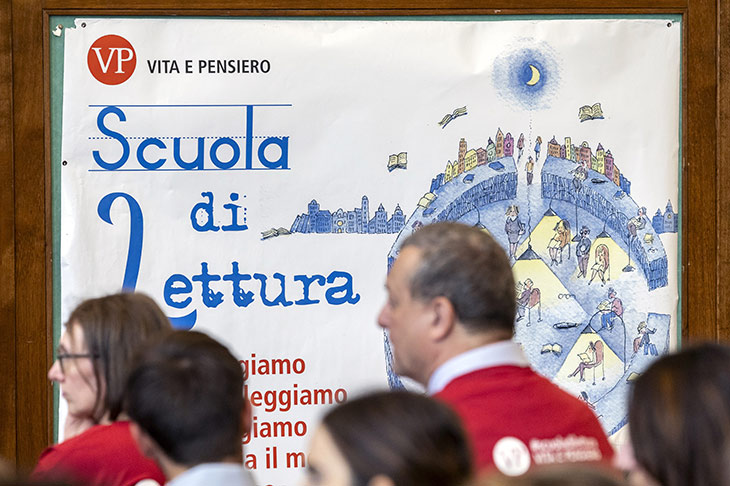Del resto, si sa – ha esordito Recalcati – che la tragedia greca e i suoi personaggi sono fondamentali per il sapere psicoanalitico. Si pensi all’Edipo di Sofocle, ma anche a Elettra, Antigone, considerando lo straordinario lavoro che Lacan fa su questa figura, o a Telemaco. Il principale «riferimento mitologico» della psicoanalisi è il mondo greco.
Eppure, la psicoanalisi «parla anche la lingua della Bibbia». Desiderio e legge, ha osservato Recalcati, sono due termini «capitali» in questo senso. Siamo abituati a pensarli contrapposti e, per certi versi, il Primo Testamento, fin dal nucleo della Torah, ne ribadisce la contrapposizione: tende infatti a concepire la legge di Mosè come opposta al movimento dinamico e strutturalmente trasgressivo del desiderio. «La legge mosaica, riletta da Paolo, impone alla forma umana della vita un imperativo fondamentale: non desiderare», ha aggiunto lo psicoanalista.
Da questo punto di vista, la legge si rivelerebbe fondamentalmente come un potere di interdizione, di limitazione, di negativizzazione della vita. In realtà, nel testo biblico, la legge non ha mai il fine di comprimere, mortificare, schiacciare la vitalità della vita, nemmeno nella formulazione mosaica. Al contrario, secondo Mosè, il suo scopo è iscrivere il «non tutto nel cuore dell’umano». In fondo, già nella Torah, il peccato dei peccati, la follia più grande dell’umano è l’aspirazione a essere tutto. Un tema, questo, ha avvertito Recalcati, tipico del nostro tempo. «La guerra, la minaccia nucleare, la riduzione del pianeta a pura risorsa da sfruttare segnano un allontanamento dell’uomo dal compito assegnatogli da Dio di essere custode della terra e di portare con sé il senso della legge come senso del non tutto».
Non a caso, nel suo magistero Gesù ribadisce che il problema «non è abolire la legge, ma portarla a compimento». Questo significa «che il non tutto non è l’esperienza del flagello di Dio che annienta la vita, ma la sua iscrizione nel cuore dell’uomo, ciò che rende possibile il desiderio come manifestazione della vita viva e capace di vita».
Ecco, dunque, il cuore della questione: «Gesù non è venuto a portare la legge, ma è venuto a portare la vita, a far divampare il fuoco sulla terra, a chiederci di aderire alla vita e alla legge del desiderio come manifestazione piena della vita», ha sintetizzato Recalcati.
L’idea di legge proposta da Gesù oltrepassa le due rappresentazioni canoniche del desiderio: quella greca, che lo concepisce come una maledizione nata da una mancanza, da una privazione, da una negatività; quella vetero-testamentaria, che lo interpreta in chiave nichilistica, come una ripetizione dell’insoddisfazione. Per Gesù, infatti, desiderio e legge non sono in una «relazione conflittuale». Nella sua visione, il desiderio non è una maledizione né è un’afflizione. E la legge, a sua volta, trova il compimento proprio nell’amore e nei gesti di cura.