
News | Milano
Giovani, partecipazione e democrazia
La ricerca curata dall’Osservatorio Giovani dell’Istituto Toniolo è stata presentata in Università Cattolica, con l’intervento del cardinal Matteo Zuppi, presidente CEI
| Agostino Picicco
01 ottobre 2025
Condividi su:

«L’intuizione dei corridoi umanitari è proteggere la vita delle persone, ma anche dimostrare che si può disciplinare un fenomeno che è mondiale ed epocale, e richiede solo di passare dal paradigma difensivo a quello della solidarietà, del lavoro, del futuro». È una frase del cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, riportata nella prefazione al volume “Libere da, libere di? Storie di giovani donne in Italia con i corridoi umanitari” (Vita e Pensiero, 2025), a cura di Cristina Pasqualini e Fabio Introini, contenente una ricerca dell’Osservatorio Giovani dell’Istituto Toniolo sui corridoi umanitari (condotta con 20 donne under 35 da diversi Paesi) attivi dal 2015 grazie alla collaborazione tra privato sociale, chiese cristiane e istituzioni per l’accoglienza a persone in condizione di grave vulnerabilità, al fine di offrire loro un futuro.
E proprio alle parole del cardinale Zuppi si è richiamata Elena Beccalli, rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, nell’intervento introduttivo alla presentazione del volume svoltasi il 29 settembre in sala Negri da Oleggio, organizzata dall’Istituto Toniolo in collaborazione con la casa editrice Vita e Pensiero.
Sul cambio di paradigma improntato alla solidarietà il rettore Beccalli ha articolato il suo contributo definendo la ricerca «una iniziativa meritevole di attenzione» perché «i dati e le evidenze empiriche consentono all’opinione pubblica di assumere maggiore consapevolezza sul tema nella sua complessità e di proporre linee di azione ragionate sulla base di accurate analisi scientifiche». Una ricerca e un convegno che, secondo il Rettore, sono in linea con quella prospettiva che mira a collocare l’Università Cattolica tra le istituzioni di pace attive nel panorama internazionale grazie alle sue attività didattiche, di ricerca, di impatto sociale e di disseminazione. Come testimonia lo stesso Piano Africa, che sta prendendo forma.
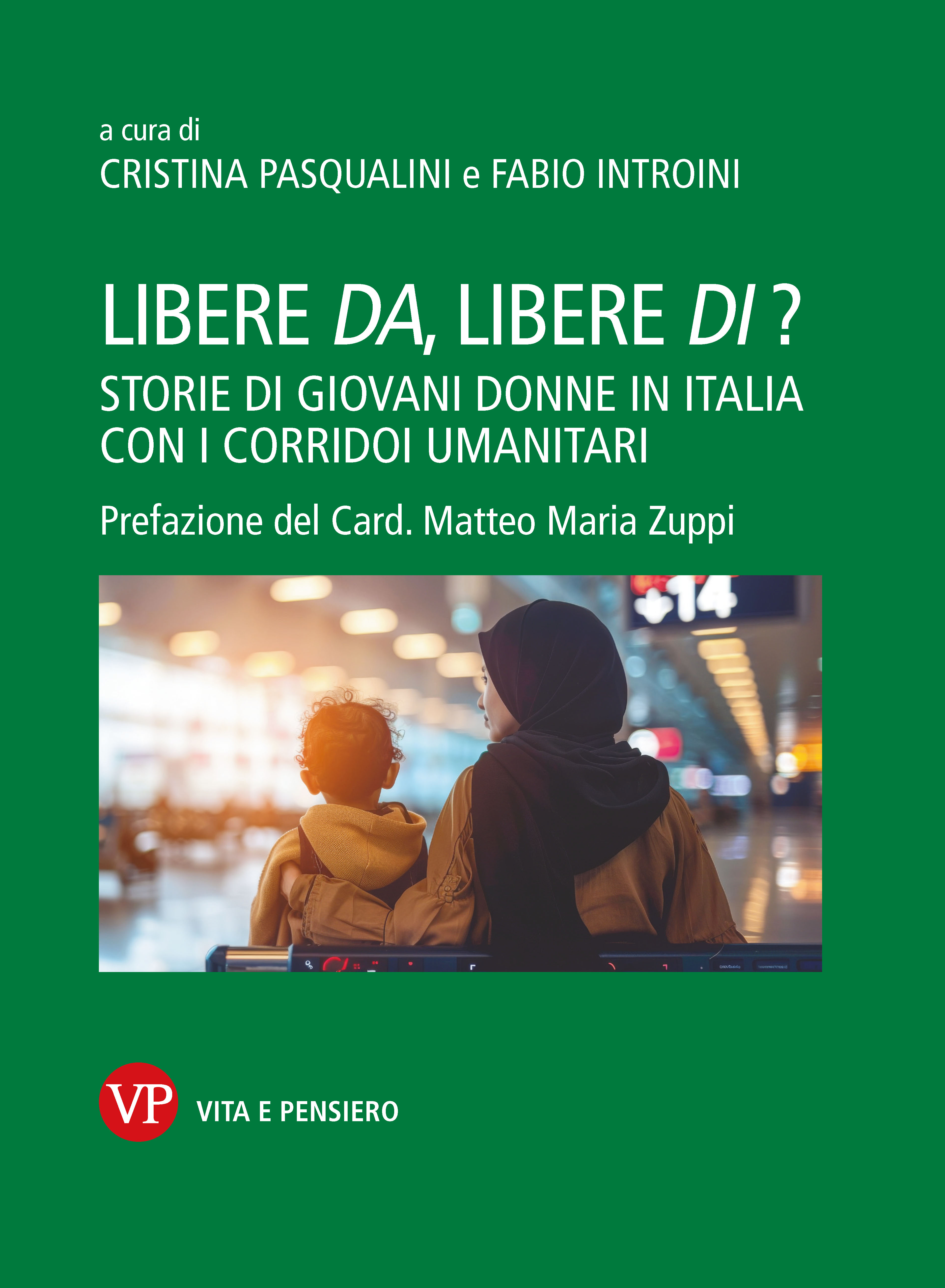 Entrando nel merito della ricerca, monsignor Giancarlo Perego, arcivescovo di Ferrara-Comacchio, presidente della Fondazione Migrantes e autore della postfazione al volume, ha ricordato che esiste ancora una «non pari opportunità» nell’accesso delle donne ai corridoi umanitari: su 122 milioni di persone in fuga le donne in cammino nei viaggi della speranza per ottenere protezione internazionale sono solo la metà. Tuttavia, ha rimarcato, occorre considerare che spesso con le donne si spostano anche altre figure fragili di cui devono farsi carico, come minori e anziani. «I corridoi umanitari non devono essere un alibi rispetto all’accoglienza e all’accompagnamento dei migranti in fuga. Le donne devono essere libere di partire o di restare».
Entrando nel merito della ricerca, monsignor Giancarlo Perego, arcivescovo di Ferrara-Comacchio, presidente della Fondazione Migrantes e autore della postfazione al volume, ha ricordato che esiste ancora una «non pari opportunità» nell’accesso delle donne ai corridoi umanitari: su 122 milioni di persone in fuga le donne in cammino nei viaggi della speranza per ottenere protezione internazionale sono solo la metà. Tuttavia, ha rimarcato, occorre considerare che spesso con le donne si spostano anche altre figure fragili di cui devono farsi carico, come minori e anziani. «I corridoi umanitari non devono essere un alibi rispetto all’accoglienza e all’accompagnamento dei migranti in fuga. Le donne devono essere libere di partire o di restare».
Ulteriori e interessanti approfondimenti sono emersi dalla tavola rotonda che ha avuto come protagoniste Alganesh Fessaha, presidente dell’Associazione Gandhi, Monica Attias, della comunità di Sant’Egidio, Monica Massari, docente di Sociologia generale all’Università degli Studi di Milano. Coordinate da Paolo Lambruschi, giornalista di “Avvenire”, si sono soffermate sull’umanità della ricerca, rispecchiata con chiarezza dalle storie dei soggetti più vulnerabili cui viene dato spazio, cioè minori e donne. Le loro testimonianze hanno squarciato un velo su episodi di torture disumane, ma anche su momenti di profonda tenerezza, quando l’accoglienza concreta ha restituito dignità a queste donne e ha accresciuto la consapevolezza di tutti noi su un fenomeno particolarmente drammatico. Come ha scritto il cardinale Zuppi: «Quando annega un migrante, annega l’intera umanità».
Tanti i temi toccati nel corso del dibattito: il cambio delle politiche migratorie, il non rassegnarsi al fatto che per migrare bisogna mettere a rischio la propria vita o metterla in mano ai trafficanti per cui «tutte le donne che arrivano sono delle sopravvissute», il restituire dignità alle donne migranti, l’idea di un’Europa come luogo di solidarietà e di umanità e non fortezza.
«Tra il saputo da noi e il vissuto da loro si spalanca un abisso»: con questa citazione Cristina Pasqualini, ha voluto sintetizzare il senso del suo intervento, dedicato alla metodologia della ricerca, costruita sui percorsi biografici. Allo stesso abisso ha fatto riferimento anche Fabio Introini, docente di Sociologia generale in Università Cattolica e curatore del volume, approfondendo le modalità dell’accoglienza e della pluralità di attori coinvolti nei progetti sul territorio. Un processo aperto alla creatività, dove l’inclusione genera altra inclusione, mettendoci il cuore accanto all’accompagnamento legale, burocratico, linguistico.
_mostra.jpg)
Un incontro denso che si è concluso con il contributo del fotografo Max Hirzel, attivo nel progetto “Human Lines, anatomia di un’accoglienza”, che ha presentato la mostra “Disegni dai campi profughi”, illustrando tramite diapositive una serie di foto a corredo della ricerca.
Anche se l’immagine più nitida che il pubblico porterà con sé di questo evento è quella dell’inchino che Alganesh Fessaha ha rivolto, all’inizio del suo intervento, ai relatori e al pubblico presente. Un gesto carico di significato, ispirato da un insegnamento ricevuto tanti anni fa dai suoi genitori: “ci si inchina davanti a chi aiuta il prossimo”. E in quell’istante, con il suo inchino, ha voluto rendere omaggio ai componenti di una istituzione universitaria, in segno di riconoscenza per il rilevante contributo dato alla pace tramite la ricerca scientifica e le attività di terza missione,
Risulta allora valido l’invito del rettore Beccalli che ha esortato a considerare questa ricerca come solo all’inizio: un cammino da proseguire per dare forza, coraggio e speranza a chi è costretto a lasciare la propria terra in cerca di un futuro degno di essere vissuto.
Un articolo di
