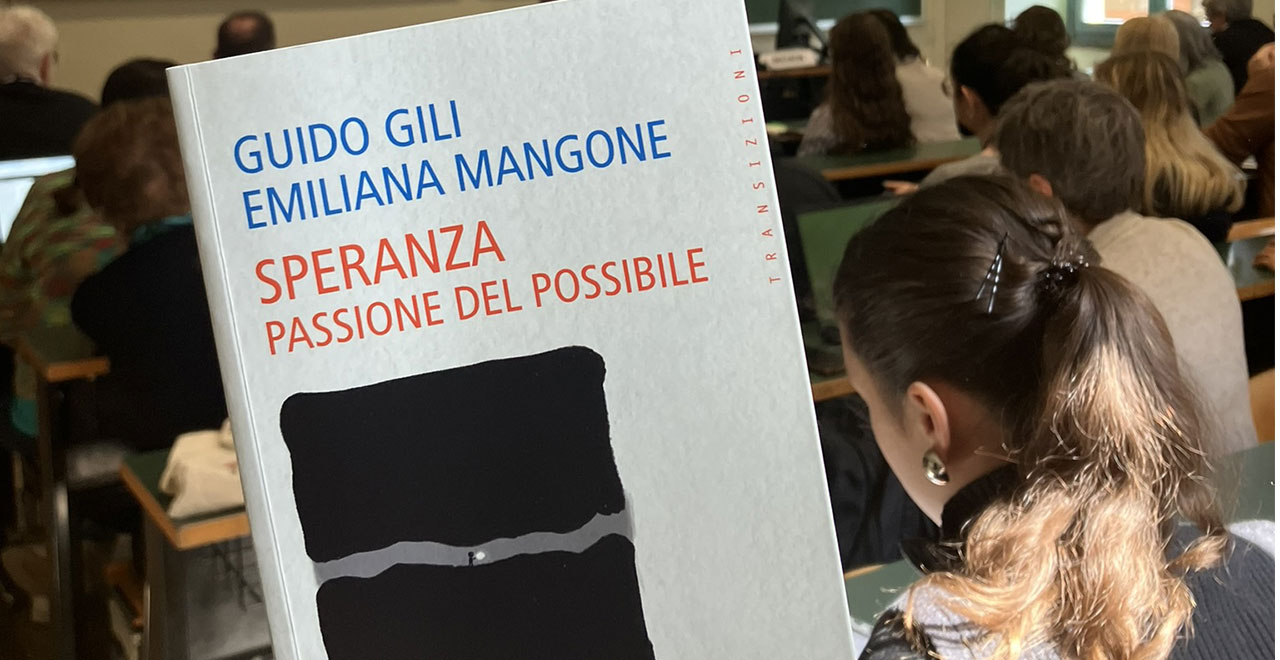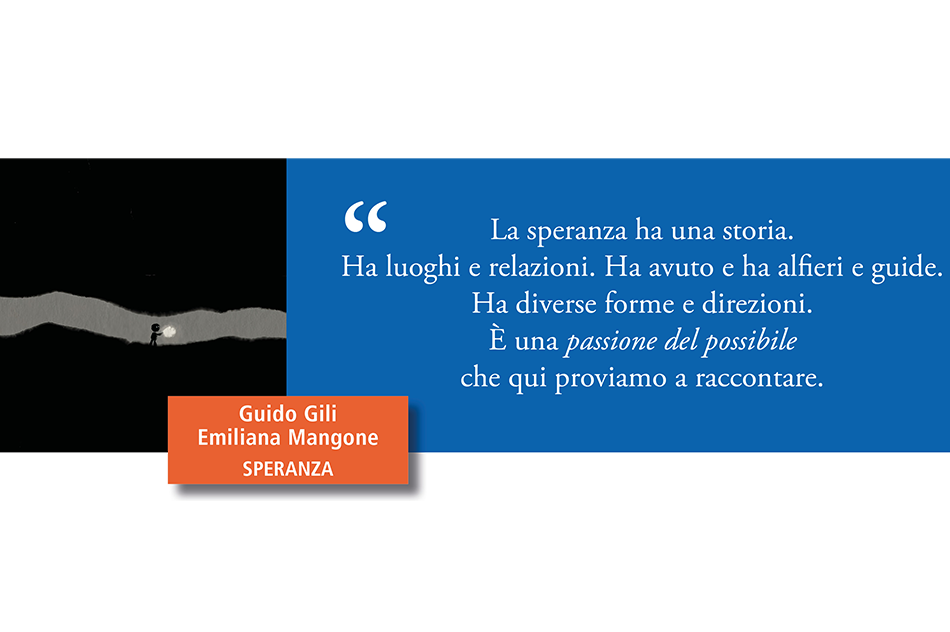Il filosofo Joseph Pieper, riprendendo un tema già presente in sant’Agostino, ha affermato, non senza ragioni, che «la speranza in senso stretto non può essere che l’atto di una persona». Tutti questi eventi, che i moderni mezzi di comunicazione di massa hanno consegnato alla nostra memoria attraverso immagini diventate memorabili, mostrano tuttavia che la speranza non è solo qualcosa che sorge, vive e deperisce ‘nelle’ persone, ma anche ‘tra’ le persone. Vi sono reti e correnti di speranza che in certi particolari frangenti storici diventano dei fiumi vastissimi e impetuosi che cambiano la storia di singoli popoli o dell’intera umanità.
Senza dubbio ognuna delle persone che ha partecipato a quegli eventi vi ha portato le ‘sue’ speranze. In che cosa sperava? Sperava che da quel giorno sarebbe sorto un mondo migliore e le cose sarebbero cambiate, sperava in una vita più dignitosa per sé e i propri figli, in un lavoro migliore, nella possibilità di potersi esprimere liberamente e senza timore e di poter partecipare alla vita politica. O tutte queste cose insieme. Certamente le speranze di un esponente dell’élite intellettuale indiana, da cui proveniva lo stesso Gandhi, erano diverse da quelle di un artigiano, un contadino o un paria, relegato in fondo alla scala sociale del grande Paese asiatico. […] Esiste infatti la speranza ed esistono le mille e una speranza degli individui e dei piccoli gruppi che si esprimono in mille e una forma e linguaggi. Ma in quegli eventi è apparso anche chiaro come le ‘piccole’ speranze particolari confluiscano e si intreccino con le ‘grandi’ speranze delle generazioni, delle classi, dei popoli. […]
La speranza è un’esperienza personale, ma è anche un fenomeno storico e sociale, dal momento che in certe epoche e in certi luoghi essa risorge prepotente, come è accaduto per esempio dopo la Seconda guerra mondiale, quando in molti Paesi, tra cui l’Italia, è iniziato un intenso periodo di elaborazione di nuove forme democratiche e partecipative, di accentuato sviluppo demografico, di ricostruzione economica, di forte mobilità orizzontale e verticale, grazie soprattutto all’investimento nell’istruzione. Non a caso, proprio durante la Seconda guerra mondiale e negli anni successivi, quasi a esprimerne lo ‘spirito del tempo’, sono state scritte o pubblicate varie opere – come Homo viator di Gabriel Marcel, Il principio speranza di Ernst Bloch, Vita activa. La condizione umana di Hannah Arendt, Umanesimo integrale di Jacques Maritain – che ponevano tutte al centro il tema della speranza. In altre epoche e in altri frangenti storici invece la speranza e la fede deviano e si corrompono, come è accaduto nelle esperienze storiche che hanno portato all’affermazione dei regimi totalitari. In altre ancora si assiste a un «collasso della speranza», per cui essa sembra sparire dall’orizzonte della vita sociale per lasciare il posto a stati d’animo di paura, di impotenza, di sfiducia e di rassegnazione. In questi momenti si smette di rischiare, di intraprendere, di creare e si vede il futuro non più come una promessa, ma come una minaccia. E le società nel loro insieme entrano in una fase di stagnazione e di decadenza, se non di vera e propria implosione.
Il Novecento ha visto un continuo alternarsi di speranze e paure, tanto che, mutuando una fortunata formula letteraria di Wystan Hugh Auden, la seconda metà del secolo è stata definita come L’età dell’ansia in riferimento a eventi come la crisi petrolifera seguita al conflitto dello Yom Kippur negli anni Settanta e la catastrofe nucleare di Chernobyl nella metà degli anni Ottanta. Anche i primi decenni del secolo che stiamo vivendo, drammaticamente inaugurati dall’abbattimento delle Twin Towers, dalle guerre che ne sono seguite e dalla crisi economico-finanziaria del 2008, non sono stati risparmiati da simili fenomeni, cosicché molti si sono riconosciuti nella definizione degli psicologi Benasayag e Schmit che, riprendendo un’espressione di Spinoza, hanno indicato questi anni come l’epoca delle «passioni tristi», un’epoca nella quale, soprattutto per chi è giovane, è difficile sperare.
Per questo conviene riprendere oggi il tema della speranza. In tanti vi si sono dedicati: filosofi, teologi, psicologi, antropologi, sociologi. Ma anche poeti, pittori e musicisti che hanno cercato di rappresentarla nelle forme dell’arte. Così come accade anche oggi nelle forme delle nuove arti, come il cinema. Anche se con accenti e sottolineature diverse, molti hanno detto che la speranza è un’esperienza che definisce la stessa condizione umana, non solo un desiderio, un’attesa o un sogno a occhi aperti. Infatti, tutti gli esseri umani sono portati – chi più chi meno – a sperare, perché senza speranza non si può vivere.