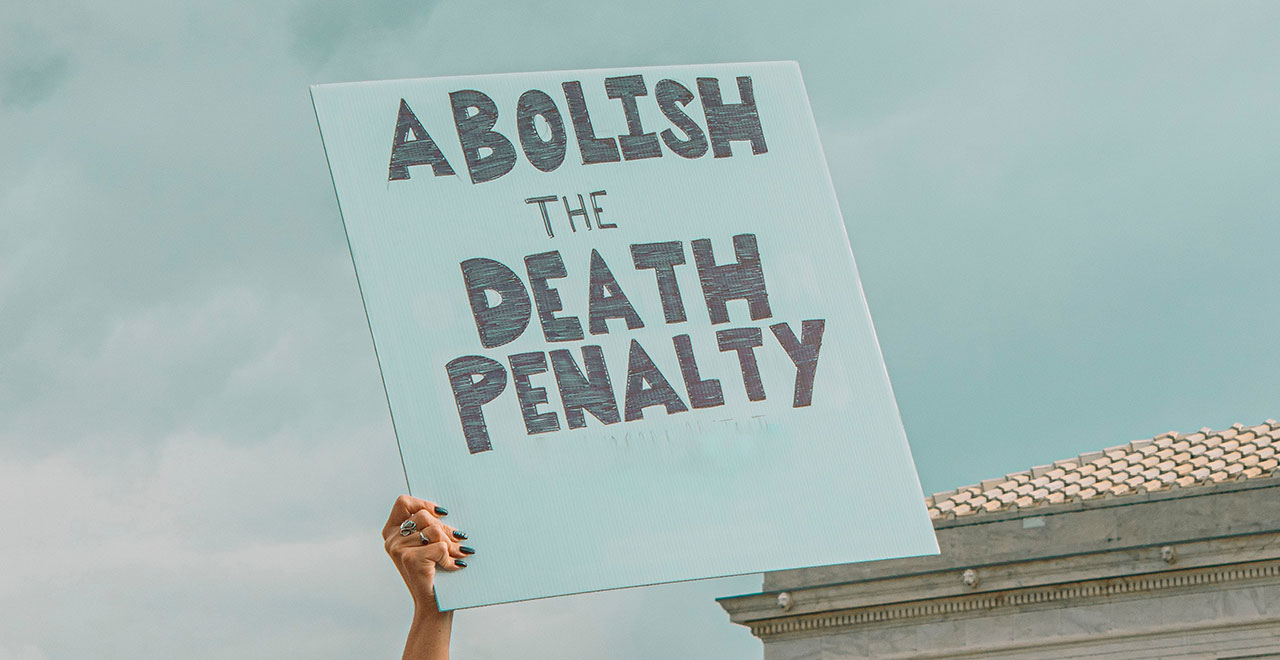Il 10 ottobre si celebra la Giornata Mondiale contro la Pena di Morte. Istituita nel 2003, l'iniziativa venne lanciata dalla Coalizione omonima - istituita dalle organizzazioni che parteciparono al Primo Congresso Internazionale contro la pena di morte a Strasburgo nel 2001 - che riunisce ONG, ordini degli avvocati, sindacati e governi locali di tutto il mondo. Obiettivo della Coalizione è quello di sensibilizzare gli Stati che ancora mantengono la pena di morte, incoraggiando l’istituzione di coalizioni nazionali e l’organizzazione di iniziative comuni per promuovere l’abolizione di tale pratica inumana. In occasione della Giornata 2023 proponiamo una riflessione della professoressa Claudia Mazzucato, docente di Diritto penale dell’Università Cattolica, che si apre con un interrogativo preciso: «Perché la giustizia è, da millenni, la virtù che ci rende crudeli e inumani?»
La pena di morte smentisce il precetto di non uccidere. Con la pena capitale, non uccidere diventa una prescrizione debole e condizionata, suscettibile di eccezioni e distinguo. Di più: la pena di morte trasforma l’eliminazione premeditata di un essere umano in giustizia, confondendo ancora più le acque tra il bene e il male, ammantando di un’aura buona e, appunto, giusta, un’azione intrinsecamente e irrimediabilmente nociva che, in quanto tale, non dovrebbe aver luogo (mai) e men che meno sotto il nome di una virtù.
Perché – ci domandiamo – la giustizia è, da millenni, la virtù che ci rende crudeli e inumani?
Nel nome della giustizia sono state, e sono ancora quotidianamente, commesse atrocità e violenze, tanto da dover indurre i costituenti di mezzo mondo (Italia inclusa) e gli estensori dei trattati internazionali sui diritti umani a esplicitare il divieto categorico di trattamenti crudeli, disumani e degradanti nell’amministrare la virtù civica e relazione per eccellenza. Il divieto espresso è il segno eloquente della diffusività di pratiche brutali legittimate come giuste, e quindi non solo giustificate ma affermate come necessarie o persino positive.
La pena di morte è forse il vertice nella scala dell’incoerenza nel rispondere alle ingiustizie. Se l’Italia può dirsi un Paese completamente liberato da questa sanzione funesta – un Paese in cui anche la vita dell’assassino è degna, perché «pari» è la dignità di ogni persona, come sancisce la Costituzione – siamo ancora lontani dall’avere un sistema sanzionatorio davvero coerente, cioè un sistema che non scende a patti con il rispondere al male con il male, il rispondere al male ingiusto del reato con il male giusto della pena. Sono stati fatti passi avanti – è vero – da ultimo con l’introduzione delle pene sostitutive e della giustizia riparativa in materia penale, eppure molto di più potrebbe (e dovrebbe) essere fatto, fino a una riforma complessiva e razionale non solo dell’intero sistema sanzionatorio ma del codice penale nel suo complesso (quello vigente è ancora il codice del 1930).
Da migliaia di anni, in tutti i luoghi del mondo, continuiamo a farci forti di un’idea che, anziché favorire lo sforzo di essere giusti, ci ha reso e ci rende ogni giorno dei giustizieri.
A dispetto della mole di studi e dati empirici che dimostrano la miopia della concezione retributiva della giustizia, sembriamo essere universalmente (chi più, chi meno) affezionati e intimamente legali a quella che con sapida lungimiranza il giurista Gabrio Forti e il filosofo Silvano Petrosino chiamano la «logica follia» dell’«illusione della giustizia» (Logiche follie, Vita e Pensiero, 2022): cioè che, sacrificando la vita, la libertà o la dignità del colpevole, i conti tornino e tutto si rimetta a posto. Non è così.
Il settore della giustizia penale è, tra tutti campi di attività umana, quello che nei secoli è cambiato meno e meno ha saputo innovare. Nel terzo millennio inoltrato, nel mondo, oltre alla pena di morte, continuiamo a usare gabbie e strumenti di contenzione e neutralizzazione, magari mettendo al servizio di questi scopi antichi, atavici e immutati le innovazioni, queste sì, della tecnologia e della scienza.
C’è materia per più di una riflessione: antropologica, sociale, politica, giuridica, ecc.
Vi sono, per chiudere con una nota positiva, tentativi molto promettenti di portare «innovazione partecipativa» nel luogo «improbabile» dell’amministrazione della giustizia (sono espressioni di Alber Dzur, Democracy Inside. Participatory Innovation in unlikely places, Oxford University Press, 2019). Basti pensare alla giustizia riparativa, divenuta legge in Italia esattamente un anno fa, che per qualunque reato offre la possibilità di un incontro libero e volontario, spalancato sulla riparazione, tra la vittima, la persona indicata come autore dell’offesa e altri eventuali soggetti con effetti penalmente rilevanti. Ma non è l’unica, né l’ultima, novità, essendo fervido il dibattito globale intorno, per esempio, a forme di giustizia ‘trasformativa’ (tranformative justice) e ‘responsiva’ (responsive regulation), giocate, in estrema sintesi, su risposte alle ingiustizie di tipo volontario, costruttivo, dinamico, correttivo e rivolte al futuro.
Foto di Maria Oswalt su Unsplash