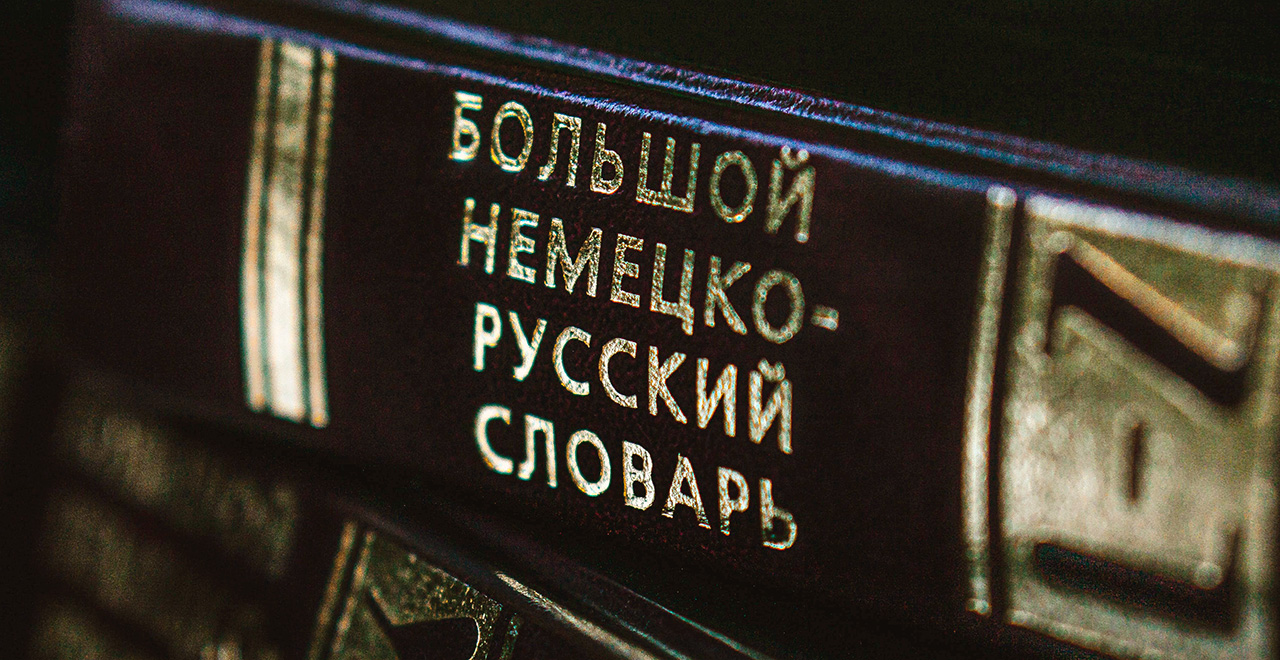In occasione della Giornata Mondiale della Lingua Russa che si celebra il 6 giugno, la professoressa Anna Paola Bonola, docente di Lingua e linguistica russa della Facoltà di Scienze linguistiche e letterature straniere, ci descrive e racconta origine, caratteristiche e peculiarità di una lingua che se da una parte è uno straordinario veicolo di cultura dall’altra è la lingua del partito unico, della propaganda, chiamata anche “lingua di legno” per il suo carattere rigido, burocratico e astratto.
Originatosi a partire dal XIII secolo dallo slavo orientale, il russo è oggi parlato da circa 140 milioni di cittadini russi, e fuori dai confini del Paese molti sono coloro che lo padroneggiano perfettamente: in Bielorussia e Ucraina il bilinguismo è comune, giacché il russo è stato lingua di comunicazione ufficiale nell’impero zarista e quindi nell’Unione sovietica. Per questo ancora oggi si può lavorare a Tbilisi o a Baku, ad Astana, Minsk o Kiev (almeno prima del tragico 24 febbraio 2022) utilizzando il russo.
Come tutte le lingue, anche quella russa è uno straordinario veicolo di cultura. E se la cultura e la storia russe sono segnate dai paradossi, il russo è uno di questi, una lingua tanto viva e duttile, quanto morta e sclerotizzata.
Il russo vivo ha saputo accogliere in sé sia la raffinata tradizione spirituale greco-bizantina, sia la componente asiatica dei tataro-mongoli con la loro pratica pagana del potere e del commercio; ha poi ospitato le lingue dei suoi riferimenti culturali e politici: i prestiti dalle lingue del nord Europa introdotti da Pietro il Grande, il francese della corte di Caterina II e della società cosmopolita di inizio Ottocento, l’italiano degli architetti e dei musicisti, fino ai tanti anglicismi entrati dopo il crollo dell’Unione sovietica.
«Senza limiti e viva come la vita, la nostra incredibile lingua sa arricchirsi di istante in istante», dice Gogol’, grande prosatore dell’Ottocento russo accanto a Puškin, Dostoevskij e Tolstoj. La lingua russa dimostra questa capacità di arricchirsi facendo trasparire l’esperienza dalla forma stessa delle parole, per cui l’orso è chiamato “mangiatore di miele” (medved’) e l’avverbio “sufficiente” indica ciò che arriva al livello del desiderio (do-vol’-n-o). Al vertice della ricchezza abbiamo la lingua dei poeti, da Puškin (ancora lui!) a Mandel’štam, Achmatova, Majakovskij e molti altri.
Accanto a tanta vitalità emerge il rigor mortis dell’ideologia: il newspeak sovietico, la lingua del partito unico, della propaganda, che uccide i significati delle parole vive o le sopprime del tutto, è stata chiamata anche “lingua di legno” per il suo carattere rigido, burocratico e astratto. Questo è successo alla lingua nell’età sovietica, e la resistenza si è combattuta nel russo stesso, quello della letteratura clandestina e della poesia, ma anche degli affetti e dell’intimità quotidiana.
Oggi che la lingua russa è tornata a essere usata, dai governanti del paese, come strumento di oppressione, scrive la filologa moscovita Svetlana Panič: “Noi non sappiamo più come essere Puškin […] Si è come svuotato l’enorme forziere nel quale potevamo trovare parole di sostegno e ispirazione, che ci suggeriva il senso delle parole quando le parole stesse si svuotavano e noi facevamo fatica a parlare. […] Alla nostra lingua è successa una cosa molto dolorosa: è stata “occupata”, occupata dall’ideologia della guerra”. Ma seguendo Michail Bachtin possiamo dire: “Non c’è niente che sia del tutto morto: ogni senso avrà la sua festa di resurrezione”.
Photo by Cedrik Wesche on Unsplash