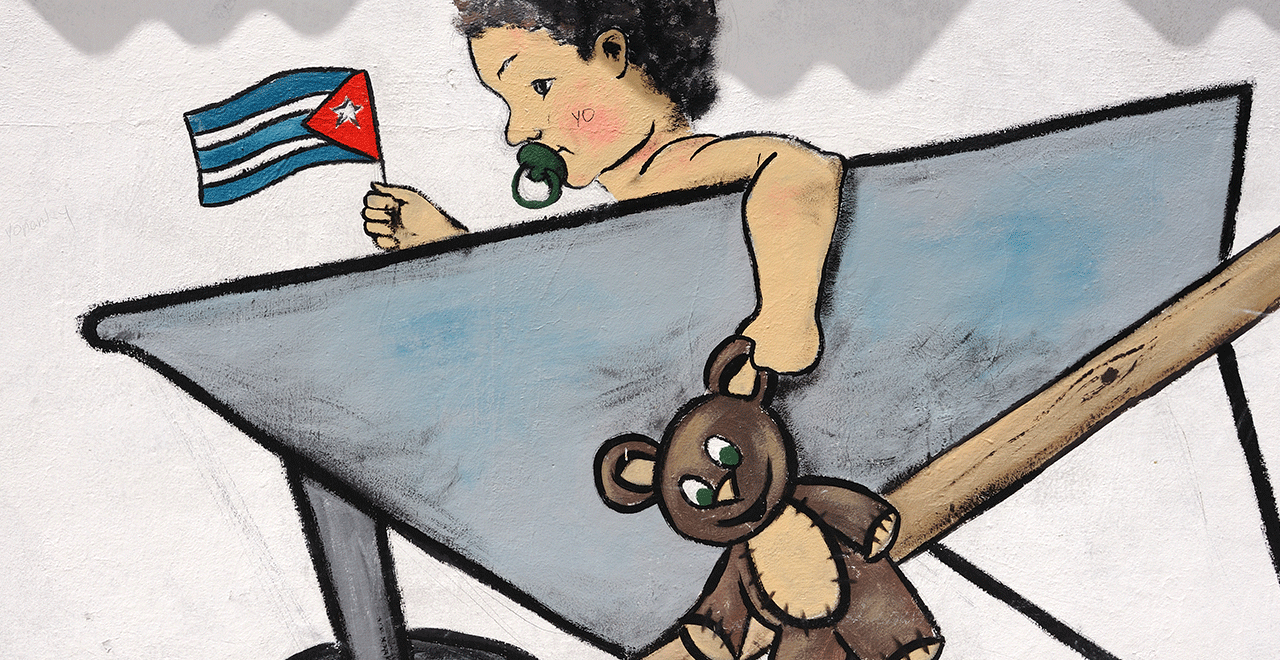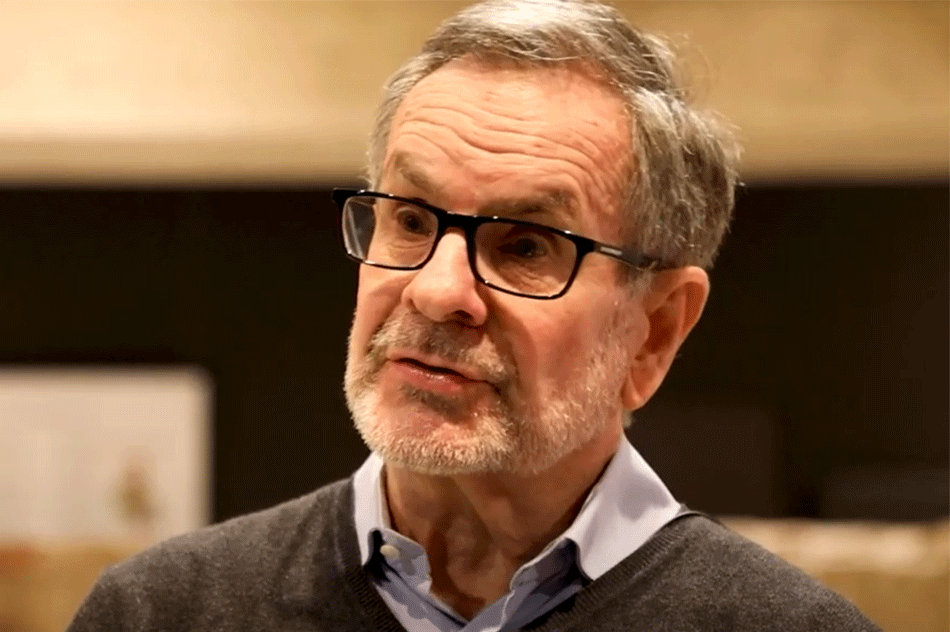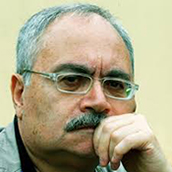Martedì 29 marzo 2022, le Cattedre di Lingua e Letteratura Spagnola e Ispano-americana dell’Università Cattolica hanno presentato, nel ciclo “Incontri con l’autore”, una conversazione con Manuel Barriuso Andino, docente di lingua spagnola presso l’Università dell’Insubria. Barriuso è il protagonista di una storia che viene raccontata nel film “Un traduttore”, diretto dai figli Rodrigo e Sebastián Barriuso. Quanto segue è un riassunto dell’incontro, tenuto dalla professoressa Michela Craveri e il professor Dante Liano.
Quando il professor Manuel Barriuso Andino si presentò nella sua aula nell’Università di L’Avana, per la solita ora del corso di letteratura russa, trovò un cartello sulla porta in cui si annunciava che le lezioni erano sospese. Accanto al cartello, una busta con una lettera a lui indirizzata. Barriuso la aprì. Lesse, con meraviglia, che le autorità universitarie gli ordinavano di presentarsi all’Ospedale Nazionale. Quando varcò la soglia dell’Ospedale, una sorpresa lo attendeva.
Barriuso apparteneva a una famiglia di ottima tradizione culturale. Il padre era economista e lavorava alla Banca Centrale di Cuba. Questo gli aveva permesso di avere una bella casa nel quartiere di El Vedado, un complesso residenziale appartenuto alla borghesia benestante prerivoluzionaria. Lungo strade alberate e giardini curati, piccoli palazzi stile anni 50 dimostravano che l’Avana era stata, da sempre, una delle capitali più belle e fiorenti dell’America Latina. Verso gli anni 70, El Vedado era abitato da funzionari statali, professori universitari, musicisti, poeti, artisti. Anche con le poche risorse che avevano, gli abitanti curavano le case con maggior impegno di quelli di L’Avana Vecchia. La posizione del padre aveva permesso a Barriuso un lusso: avere una macchina, e non una macchina qualsiasi, ma una chicca per l’epoca: una Fiat 128, di un design che evocava più l’eleganza che la velocità.
Quando finì la secondaria, Barriuso si presentò agli esami d’ammissione della Scuola di Giornalismo. Fu bocciato: non apparteneva al Partito Comunista e, inoltre, era un ragazzo irrequieto. La preside della Scuola lo chiamò e gli disse: «Senti, visto che sei una testa calda, il tuo luogo ideale è la Russia», e gli offrì una borsa di studio a Leningrado (oggi San Pietroburgo). Quando Barriuso comunicò alla famiglia la sua intenzione di studiare nell’Unione Sovietica, il padre commentò, lapidario: «Visto che non hai imparato l’inglese, non imparerai nemmeno il russo. Nel giro di un anno sarai di ritorno». Invece, Barriuso restò per cinque anni, e s’immerse nella grande cultura di quel paese. «Ammiro soprattutto Chechov - dice con entusiasmo - fra Dostoevskij e Tolstoj, scelgo la sua perfezione». E raccomanda di ascoltare “La Barcarola”, di Tchaikovsky. Fa un gesto, dondolando la testa: «È come essere sul mare» afferma mentre chiude gli occhi.
Di ritorno a L’Avana, entrò in Università come professore di letteratura russa. La sua vita trascorreva nella routine di un professore universitario, con la bella casa nel Vedado e la 128 ereditata dal padre. Ha un motto di sdegno: «A Bruxelles, qualcuno mi ha detto che avevamo una vita sofisticata. No, non eravamo ‘sofisticati’!». Dà l’impressione che la parola suoni come un attacco al suo stile di vita di quell’epoca, che fu molto dura per i cubani. «Noi eravamo proletari», afferma. Usa quella parola. «Vivevamo del nostro stipendio, mio padre, mia madre, mia moglie e io. Eravamo lavoratori della cultura». Ha ragione: il comunismo cubano non permetteva disparità di salari fra le diverse professioni. E gli stenti degli uni erano quelli degli altri, nei periodi di maggior crisi economica. Vero è che la élite culturale cubana non smise mai di avere degli alti rappresentanti in tutti i campi dell’arte: poeti, narratori, musicisti, compositori erano e continuano a essere al più alto livello mondiale.