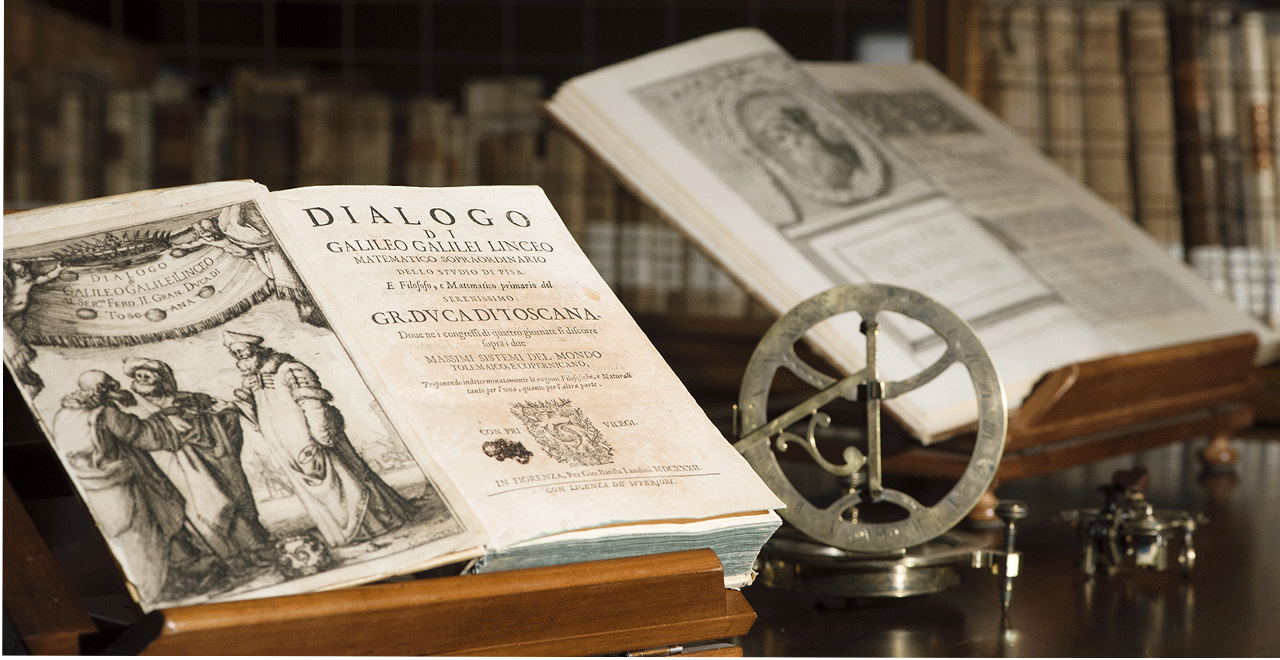Si concluse nella casa bresciana dell’ing. Carlo Viganò l’accordo di donazione siglato il 10 aprile 1973 con il rettore Giuseppe Lazzati, già avviato nel 1971. Da quel giorno iniziarono i lavori per far nascere la ricchissima biblioteca di Storia delle Scienze, una raccolta di circa 10.000 volumi di materia scientifica, nell’accezione più ampia dell’espressione, divisa più o meno equamente tra fondo antico e fondo moderno (comprende quindi manoscritti, incunaboli, cinquecentine ed edizioni dal XVII al XIX secolo).
Ospita opere e prime edizioni dei più eminenti scienziati della storia a partire da Archimede, Euclide, Apollonio di Perga, giungendo a Niccolò Copernico, Galileo Galilei, Giovanni Keplero, Isaac Newton, passando per i bresciani Niccolò Tartaglia, Benedetto Castelli e Francesco Lana de’ Terzi. Fra questi troviamo la prima edizione de Il saggiatore di Galileo Galilei, pubblicato 400 anni fa e di cui si parlerà nel seminario "Impareggiabile testimonianza di esemplare generosità", di mercoledì 3 maggio.
«Nessuna opera meglio del Saggiatore ci aiuta a capire la concezione che Galileo aveva della scienza – spiega Franco Giudice, docente di Storia della scienza. Nata dalla disputa con il gesuita Orazio Grassi sulla natura delle comete apparse nei cieli autunnali del 1618, il libro va ben oltre l’oggetto della polemica scientifica: è a tutti gli effetti un “discorso sul metodo”, che esprime la piena consapevolezza della portata rivoluzionaria del nuovo sapere, inaugurato dallo stesso Galileo con le straordinarie scoperte telescopiche del 1610, quando aveva ridisegnato la geografia del mondo ed esteso i confini dell’universo. È nel Saggiatore che Galileo espone la sua celebre dottrina secondo cui la natura è dotata di un ordine e di un’armonia di tipo geometrico, che va quindi letta come un libro. Non un libro di quelli scaturiti dalla fantasia dei poeti, ma un libro scritto in linguaggio geometrico, che può essere compreso soltanto da chi è in grado di “conoscer i caratteri, ne’ quali è scritto” (triangoli, cerchi, etc.). Non solo: il Saggiatore è un capolavoro di scrittura, con una prosa scintillante che rappresenta una delle vette più alte della letteratura italiana del Seicento, dove la ricchezza del registro linguistico è sempre ancorata al rigore scientifico delle argomentazioni. Tutti elementi che, non a caso, erano tanto apprezzati da autori come Leopardi e Italo Calvino».
Durante il seminario Diego Cancrini, collaboratore delle Raccolte storiche, attraverso una ricostruzione documentaria, racconterà il percorso che portò la Biblioteca Viganò in Università, nel periodo intercorso tra la manifestazione della volontà dell’ingegnere (agosto 1971) e l’effettiva donazione con il conseguente arrivo della stessa a destinazione (aprile e tardo autunno 1973).
Ancora legato a Galileo sarà invece l’intervento di Michele Camerota, docente di Storia della scienza all’Università di Cagliari, che si concentrerà sull’attività del prof. Antonio Favaro, il più grande esperto di Galileo del secolo scorso, in relazione alla sua Edizione Nazionale delle Opere galileiane, maestosa impresa scientifica ed editoriale portata a compimento negli anni tra il 1890 e il 1909.
Simona Gavinelli esporrà i risultati del proseguimento delle sue ricerche sul “Fondo Autografi” della Biblioteca Viganò, che già l’avevano condotta alla pubblicazione del volume La scrittura dello scienziato. Il Fondo autografi della Biblioteca di Storia delle Scienze «Carlo Viganò» dell’Università Cattolica di Brescia (Roma-Bristol, «L’Erma» di Bretschneider, 2021). I nuovi documenti, conservati in faldoni non ordinati, includono autografi di importanti uomini di scienza tra il XVIII e il XIX secolo, tra i quali Pietro Caldani, Baldassarre Boncompagni Ludovisi e Angelo Secchi. Marco Zanini parlerà, invece, di alcune teorie sull’istruzione femminile circolate a Brescia, e in tutta la Repubblica veneta, verso la metà del XVIII secolo, con particolare attenzione alla formazione scientifica delle dame bresciane Giulia Baitelli, Camilla Solar d’Asti, Lodovica Fè e Diamante Medeglia.