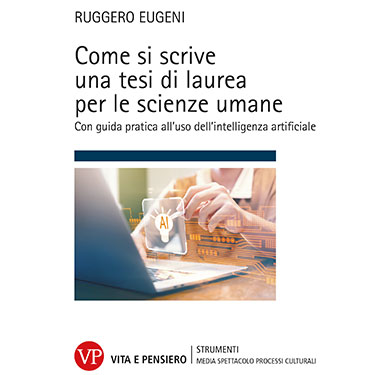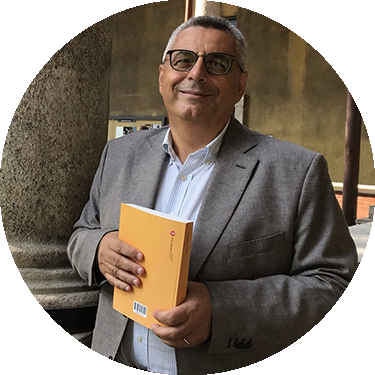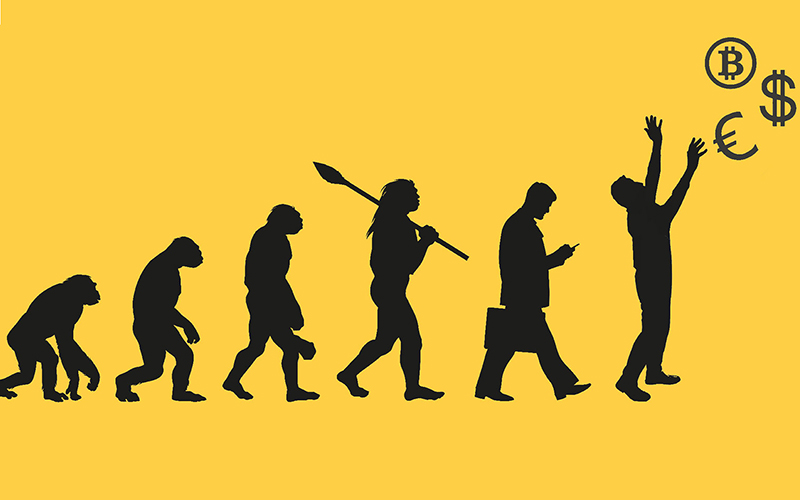Mercoledì 15 ottobre alle ore 18 al Collegio Augustinianum dell’Università Cattolica (Milano, via Ludovico Necchi, 1) verrà presentato il libro di Paolo Gomarasca – ordinario di Filosofia morale dell’Ateneo e Francesco Stoppa, "Salviamo la cosa pubblica. L’anima smarrita delle nostre istituzioni" (ed. Vita e Pensiero), in dialogo con il filosofo Massimo Cacciari. Il dibattito, introdotto dal direttore del collegio Matteo Dominidiato, ruoterà attorno alcuni temi chiave della Res Pubblica (politica, scuola, cura, spazi pubblici) prendendo spunto dalla forma del volume, costruito come un dialogo epistolare tra i due autori. Di seguito un estratto dal capitolo conclusivo "Spazio al comune".
Francesco aveva un orto. Questo fatto può sembrare a prima vista abbastanza scontato, tenuto conto che, nel Medioevo, la presenza dei giardini e degli orti era assai diffusa, più o meno a tutti i livelli della scala sociale e, ovviamente, anche all’interno delle mura monastiche. Ma se ci pensiamo un attimo, la cosa è abbastanza strana, perché stiamo comunque parlando di un uomo che era dedito a una vita itinerante, fatta di mendicanza porta a porta. Quindi una vita sostanzialmente diversa dalla stabilità geografica che un orto sembrerebbe implicare. Per non parlare del fatto che le prime Regole escludevano in maniera categorica la proprietà privata di qualsiasi bene, soprattutto di terre. E aggiungiamo pure che una delle proibizioni più severe di Francesco riguardava la possibilità di metter via qualcosa da mangiare per il futuro, nemmeno mettere a bagno la sera i legumi per l’indomani, perché occorreva combinare in modo infrangibile due principi irrinunciabili: una fiducia illimitata nella provvidenza e uno stato di precarietà assoluta. A che fine, dunque, tenersi un pezzo di terra, se non è per capitalizzare scorte di cibo?
Ora, dobbiamo a Tommaso da Celano, primo biografo ufficiale di Francesco, il racconto di quest’orto. Forse c’è innanzitutto un motivo letterario consolidato: avere un orto è un topos agiografico assai comune, è come dire che il santo si è ritirato dal teatro degli affari economici, optando per un regime di autosufficienza. Poi c’è senz’altro un motivo teologico: gli orti medievali, specialmente quelli collegati alle istituzioni religiose, sono simbolo del giardino dell’Eden o addirittura del grembo verginale di Maria, sovente associato – a sua volta – all’hortus conclusus del Cantico dei Cantici. Infine, possiamo mettere in conto anche un motivo politico: al tempo in cui molti movimenti radicali pauperisti erano considerati francamente eretici, Tommaso sembra voler legittimare il nuovo ordine francescano, cercando di renderlo un po’ simile ad altri ordini monastici assai ben visti, come ad esempio quelli che seguivano la Regola benedettina, nella quale si fa per l’appunto ampia menzione di giardini e orti coltivati.
Tutti questi motivi sembrano plausibili. Ma l’aspetto che ci deve interessare maggiormente è il fatto che Tommaso ci racconta, sì, dell’orto di Francesco, ma perché vuole innanzitutto dirci che aveva delle caratteristiche speciali, che nessun altro orto o giardino medievale possedeva. Così veniamo a sapere che «[Francesco] ordina che l’ortolano lasci incolti i confini attorno all’orto, affinché il verde delle sue erbe e lo splendore dei fiori cantino quanto è bello il Padre di tutto il creato. Vuole pure che nell’orto un’aiuola sia riservata alle erbe odorose e che producono fiori, perché richiamino a chi li osserva il ricordo della soavità eterna».
Queste poche righe possono fornirci un buon punto di accesso alla anomala topologia ‘francescana’. La prima anomalia è senza dubbio quella di non volerlo delimitare. È una cosa che ci mette a disagio, perché la classica scansione topologica dentro/fuori qui non funziona: non vi è traccia di recinti e tantomeno di muri. Eppure, l’orto è tale, nel Medioevo, proprio perché chiuso, altrimenti chiunque potrebbe entrare. L’ortolano di Francesco, invece, non ha questo genere di preoccupazioni da latifondista e quindi non perde tempo a difendere uno spazio aperto. Insomma, potremmo dire che la topologia dell’orto francescano suggerisce la regola dell’ospitalità. Anzi, azzardiamo, si configura come una specie di res publica in miniatura.
Poi la questione del non-tutto coltivato. Suona come un invito a svegliarsi dal sonno colonialista, da quella spinta a voler addomesticare il mondo. Giusto e doveroso coltivare, è l’originario mandato divino, così come compare nel racconto di Genesi. Ma sapere che ai bordi dell’orto preme una bellezza che è fuori dal nostro controllo, ci aiuta a non prenderci troppo sul serio. Dobbiamo allora temere l’invasione delle ‘erbacce’? Tipica reazione da border-maker. Francesco è di altro avviso: il verde selvatico non ha meno valore dei nostri ortaggi, proprio perché ci insegna a lasciare spazio all’incalcolabile.
E questo ci porta all’hortulum in horto, espressamente dedicato alla coltivazione di piante profumate e belle da vedere. Come dire che Francesco vuole un orto aperto non solo verso l’esterno, ma anche al suo interno, disponibile – cioè – a fare spazio a un tipo coltivazione diverso, estraneo alla produzione di cose utili (tipo erbe medicinali, che infatti erano abbastanza diffuse negli orti medievali) o cose buone da mangiare. Questa seconda anomalia topologica è forse ancora più spaesante.
Ma Tommaso conosce il Cantico di Frate Sole, quindi sa bene che Francesco sta lanciando un messaggio a quanti ragionano in termini strettamente utilitaristi: «Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra matre terra, la quale ne sustenta et governa, et produce diversi fructi con coloriti flori et herba». Ecco, la terra non ci dà solo il sostegno alimentare dei frutti, ma anche il ‘sostegno estetico’ dei fiori colorati. Non di solo pane, potremmo dire.
L’orto di Francesco è pensato così, con questa doppia logica: c’è un servizio produttivo dei beni di consumo e c’è anche il servizio non-produttivo della bellezza, che ovviamente per lui è inno al Padre del creato. Una bellezza fuori mercato, da leggere – se possibile – in tutta la sua portata polemica, nei confronti di quello sfruttamento della terra che, tra il XII e il XIII secolo, comincia a prendere velocemente le sembianze della futura economia agricola capitalista.
Sicché non ci deve sfuggire nemmeno quel «et governa», spesso interpretato un po’ sbrigativamente come un sinonimo di «sustenta»: la verità, secondo Francesco, è che la terra non è solo al nostro servizio. Ha anche un potere su di noi. Un potere non tirannico, che a Francesco suggerisce giustamente la cura materna e la solidarietà fraterna. Ma pur sempre un potere che va tenuto in conto, con umiltà, come fosse il segnale di un limite non valicabile, messo lì per ricordarci che non siamo noi a reggere le sorti dell’universo. In fondo, noi stessi siamo terra.
Questa fondamentale finitezza era certamente più chiara agli antichi, come si può ben vedere nel primo stasimo dell’Antigone di Sofocle: certo, l’uomo è una meraviglia senza pari, recita il Coro, perché ha imparato a rivoltare la terra con l’aratro, anno dopo anno; ma tutti sanno che la terra è pur sempre «la più eccelsa tra gli dei». E oggi? Oggi la terra è il gadget più grande di tutti. Quindi l’orto di Francesco funziona come un principio di contestazione, utile per ripensare a fondo che cosa significa stare al mondo.