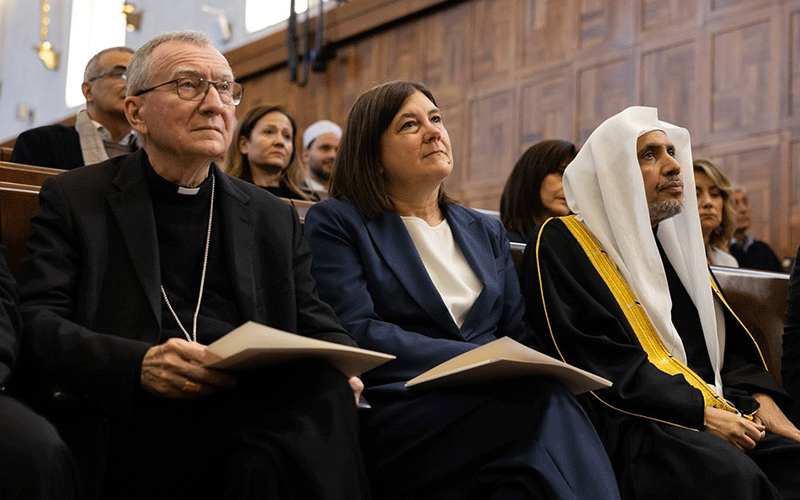Cari Mons. Giuliodori e sacerdoti concelebranti,
Cara Prof.ssa Beccalli, Rettore, e docenti,
Cari giovani,
Fra non molti giorni ci sarà la conclusione delle lezioni e si farà rientro in famiglia per festeggiare il Natale. Le vacanze sono sempre molto gradite agli studenti (e anche agli insegnanti!), perché sono l’occasione per sentire con maggiore intensità la vicinanza delle persone care e il calore degli affetti.
Immagino che uno dei desideri più intensi dei vostri genitori e dei vostri familiari a Natale sia quello di radunare attorno ad un unico tavolo imbandito i figli e i nipoti, tutti insieme. Se ne dovesse mancare anche uno solo, proverebbero un sentimento pungente, che definirei come “nostalgia dell’assente”.
Questo sentimento ci mette in sintonia con il cuore inquieto del pastore del Vangelo odierno che, non contento delle novantanove pecore presenti all’appello, si mette in cerca dell’unica che non c’è. Quasi a dire che non ne deve mancare proprio nessuna. Perché se manca un solo essere umano, in qualche modo è come se mancassero tutti. Un grande padre della Chiesa del IV secolo si chiedeva: «Dove vai a pascolare, o buon Pastore, tu che porti sulle spalle tutto il gregge? Quell’unica pecorella rappresenta tutto il genere umano che hai preso sulle tue spalle» [1]. Andando a recuperare quell’unica pecora dispersa, un uomo o una donna smarriti, è come se il buon pastore salvasse l’umanità intera. «Chi salva una vita, salva il mondo intero» è una frase del Talmud che tutti ben conosciamo [2]...
Papa Francesco ha commentato questo slancio del Pastore con le seguenti parole: «Si tratta di un desiderio irrefrenabile: neppure novantanove pecore possono fermare il pastore e tenerlo chiuso nell’ovile. Lui potrebbe ragionare così: “Faccio il bilancio: ne ho novantanove, ne ho persa una, ma non è una grande perdita”. Lui invece va a cercare quella, perché ognuna è molto importante per lui e quella è la più bisognosa, la più abbandonata, la più scartata; e lui va a cercarla» [3].
Ritengo che queste parole del Papa ci aiutino a percepire con maggiore consapevolezza la grande opportunità che ci è data nel far parte di un’istituzione denominata “università” e, per la precisione, “Università del Sacro Cuore”. Il termine latino universitas, infatti, è intrigante: nel medioevo indicava la corporazione di maestri e studenti che gestivano insieme l’istruzione impartita nelle città, ma, originariamente, dietro alla parola “università” ci stavano innanzitutto l’insieme del cosmo e la totalità del genere umano [4].
È una sensazione molto affascinante essere parte di una istituzione in cui convivono a fianco specializzazioni molto settorializzate e diverse tra loro, ma che in fondo concorrono ad un fine comune: offrire a voi studenti una formazione orientata a costruire assieme il futuro buono della nostra società e del genere umano.
L’università ha di mira l’universalità: tutti e ciascuno. Certamente ognuno di voi desidera laurearsi per poter trovare lavoro e così esprimere le potenzialità e realizzare i propri sogni. Questo è molto buono. Albert Einstein diceva: «Cerca di diventare non tanto un uomo di successo, ma piuttosto un uomo di valore». Saremo uomini e donne di valore, se ci sentiremo pienamente partecipi del destino comune, col desiderio di non lasciare indietro nessuno, coltivando ciascuno precisamente la “nostalgia dell’assente”.
La denominazione completa è – come accennavo poc’anzi – “Università Cattolica del Sacro Cuore”: la vostra istituzione accademica si rifà idealmente al Cuore di Gesù. Da poche settimane papa Francesco ci ha regalato un’enciclica proprio sull’amore umano e divino del Cuore di Gesù, dal titolo Dilexit nos: «Ci ha amato».
Ebbene, fra le tante esperienze riportate, il Papa ricorda pure quella di santa Gertrude di Helfta, la quale durante un colloquio mistico ha posto un interrogativo al discepolo prediletto di Gesù, quello che, durante l’ultima cena, aveva appoggiato la testa sul suo petto, in un gesto di profonda intimità. Gertrude gli ha domandato: «Perché non hai mai riferito a nessuno quello che hai sentito ascoltando le pulsazioni del cuore di Cristo?». Il discepolo le ha riservato una risposta sorprendente: «La dolcezza di questi battiti è stata riservata ai tempi moderni, affinché ascoltandoli, il mondo invecchiato e tiepido nell’amore di Dio possa rinnovarsi» [5].
Leggendo queste parole, le ho sentite immediatamente riferite a voi, carissimi studenti. Non sono forse proprio questi i tempi “moderni” cui è riservato il compito di rinnovare il mondo invecchiato? Un mondo che potrà superare la tiepidezza dell’amore verso Dio e verso il prossimo proprio mettendosi in ascolto dei dolci battiti del Cuore di Cristo… è un compito bellissimo: svecchiare questa nostra epoca entrando in profonda sintonia con il Cuore buono di Gesù, che vuole salvare l’umanità dal male, dalla violenza delle guerre e dal peccato. Non tocca forse a voi, carissimi studenti, coltivare con i vostri docenti un dialogo appassionato per generare una cultura nuova, inclusiva, dove non sia lasciato indietro nessuno? Dove nessun uomo e nessuna donna vengano esclusi; in cui si possa coltivare la “nostalgia dell’assente”…
Per descrivere questa intuizione, torno all’istituzione universitaria nata nel medioevo. Le grandi università europee sono sorte accanto a cattedrali e monasteri e in esse vivaci discussioni accademiche vedevano accomunati insegnanti e studenti nella ricerca della verità: tutti insieme a dibattere in appassionate quaestiones (le grandi domande). Ma non dimentichiamo che queste stesse università sorgevano pure vicino alle piazze e ai mercati, alle taverne e agli incroci delle vie di comunicazione, dove fremeva la vita quotidiana, in cui uomini e donne si incontravano, mangiavano e bevevano, cercando di affrontare insieme le sfide della vita.
Oggi la vita dell’uomo contemporaneo è estremamente più complicata e complessa, e anche le università si sono articolate sviluppando molteplici rami del sapere (filosofico, umanistico, scientifico, tecnico, ecc.). Il rischio della parcellizzazione dei saperi e delle specializzazioni sempre più dettagliate può talora far perdere di vista l’orizzonte più ampio entro il quale collocarci.
Recentemente Papa Francesco, incontrando docenti e studenti dell’Università Gregoriana a Roma, dopo aver chiesto se ci si stesse interrogando sull’impatto che l’Intelligenza Artificiale avrà sull’insegnamento e sulla ricerca, ha aggiunto: «Nessun algoritmo potrà sostituire la poesia, l’ironia e l’amore, e gli studenti hanno bisogno di scoprire la forza della fantasia, di veder germinare l’ispirazione, di prendere contatto con le proprie emozioni, e di saper esprimere i propri sentimenti. In questo modo, si impara ad essere sé stessi, misurandosi con il corpo a corpo con i grandi pensieri, secondo la misura della capacità di ciascuno, senza scorciatoie che sottraggono libertà alla decisione, spengono la gioia della scoperta, e privano dell’occasione di sbagliare. Dagli errori si impara. Spesso sono gli errori a colorare i personaggi dei nostri romanzi formativi […]. È la gratuità che rende tutti servitori senza padroni, gli uni servi degli altri, tutti riconoscenti la dignità di ciascuno, nessuno escluso» [6].
Ecco: «nessuno escluso». Dunque, non eliminiamo troppo in fretta la “nostalgia dell’assente”. Sentiamoci sempre parte di una universitas, di una comunità di uomini e di donne che compongono la totalità del genere umano, cui tutti possono e devono prendere parte. Mettiamoci in questo modo in sintonia coi battiti del Cuore di Cristo che desidera condurre tutti e ciascuno alla salvezza!
Sempre il Papa in Gregoriana ha aggiunto: «È necessario trasformare lo spazio accademico in una casa del cuore. La cura delle relazioni ha bisogno del cuore che dialoga. Il cuore unisce i frammenti e con il cuore degli altri si costruisce un ponte dove incontrarsi. Il cuore è necessario all’Università che è luogo di ricerca per una cultura dell’incontro e non dello scarto» [7].
Infatti, nell’intimo del Pastore buono pulsa fortissima questa nostalgia, perciò egli si lancia alla ricerca di quell’unica persona per sottrarla alle dinamiche di morte fisica e spirituale e recuperarla alla vita. Anch’io, anche tu, tutti noi talvolta ci allontaniamo e ci sentiamo persi. Allora Lui esce e va in cerca precisamente di te, di me, di quell’amico, di quell’amica…
Un quadro, cui sono molto affezionato, l’Adorazione dei pastori di Lorenzo Lotto (realizzato nel 1530) [8], mostra il bambino Gesù che dalla culla allunga la manina verso il muso di una pecora che i pastori gli porgono. Qualche critico d’arte dice che con questo gesto il neonato indica il suo destino di agnello che morirà per noi. Però, desidero offrire pure un’altra interpretazione: forse il bambino allude al mestiere che farà da grande; freme già dal desiderio fretta di andare in cerca di chi si è perduto.
Ecco, l’incanto del Natale: Gesù viene al mondo e diventa bambino perché sente l’insopprimibile “nostalgia dell’assente”. Talora l’assente, sono proprio io, sei precisamente tu. Così potremmo fare nostra l’invocazione di Sant’Ambrogio, vescovo di Milano [9] in tempi non certo tranquilli, il quale, identificandosi con la pecora, si esprimeva così: «Vieni, Signore Gesù, cerca il tuo servo, cerca la tua pecora stanca. Lascia andare le tue novantanove pecore e vieni a cercare la sola pecora che si è persa. Vieni da me… cercami, trovami, prendimi e sollevami. Vieni, Signore, perché solo tu sei in grado di far tornare indietro la pecora errante e non rattristerai quelli da cui ti sei allontanato» [10].
[1] Gregorio di Nissa, Omelie sul Cantico dei Cantici, a cura di C. Moreschini, Città Nuova Editrice, Roma 1988. p. 74.
[2] Sanhedrin, 4,9.
[3] Papa Francesco, Udienza generale, Piazza San Pietro, 4 maggio 2016.
[4] Cf. L. Castiglioni-S. Mariotti, Vocabolario della lingua latina, Loescher Editore, Torino 1974, 1536.
[5] Papa Francesco, Dilexit nos. Lettera enciclica sull’amore umano e divino del Cuore di Gesù Cristo, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2024, n. 110, p. 80.
[6] Papa Francesco, Discorso del Santo Padre all’Università Gregoriana, 5 novembre 2024.
[7] Ibidem.
[8] Tela conservata nella pinacoteca Civica Tosio Martinengo di Brescia.
[9] Precisamente quest’anno, ricorrono i 1650 anni dalla sua ordinazione a vescovo di Milano!
[10] Ambrogio, Commento al Salmo 118 22,28-20.