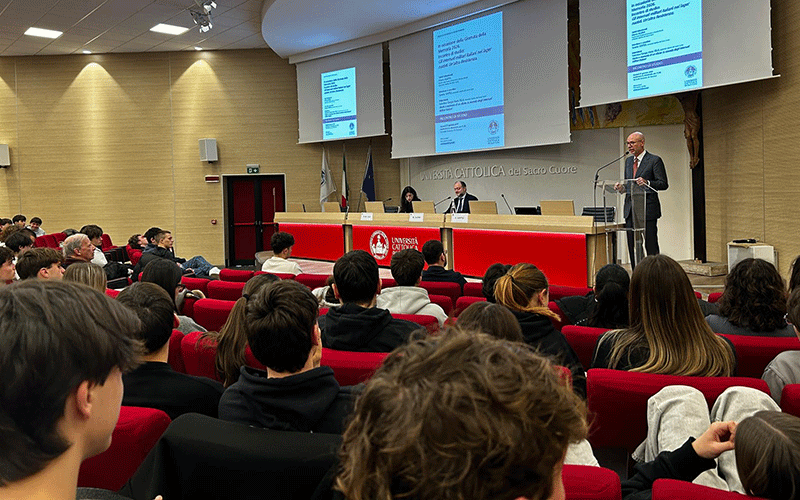Celebrare la Giornata per la Memoria non è solo un atto doveroso nei confronti della Storia e rispettoso verso tutte le vittime dell’atrocità del nazismo, ma è anche un modo per sensibilizzare le nuove generazioni al valore dell’umano e all’attitudine a preservarlo. Anche l’uso delle immagini della Shoah non può prescindere da questo ideale.
Quest’anno l’Università Cattolica e la Fondazione Memoriale della Shoah di Milano, insieme con Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea - CDEC, Fondazione Gariwo, UCEI - Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, e Associazione Figli della Shoah, lo scorso 15 gennaio hanno promosso l’evento “Le immagini della Shoah tra storia e propaganda”. Immagini non solo come testimonianze vive ma anche come strumenti per raccontare, influenzare ed educare. Tre interventi di studiosi e alcuni laboratori hanno analizzato il linguaggio d’odio, la propaganda antiebraica e il ruolo delle rappresentazioni visive nella costruzione della storia e della memoria della Shoah.
Dopo i saluti del presidente della Fondazione Roberto Jarach che ha a cuore la sensibilizzazione del mondo della scuola su quanto la Memoria porta con sé, la prorettrice dell’Università Cattolica Anna Maria Fellegara ha ricordato l’impegno costante dell’Ateneo per la Memoria e la sua fiducia nel potere dell’educazione «per formare cittadine e cittadini consapevoli del loro ruolo e capaci di assumerlo grazie allo studio e all’approfondimento. Il potere trasformativo della società – ha dichiarato – passa attraverso la formazione».
Per combattere l’antisemitismo occorre tenere presente che, a partire dal divieto dell’ebraismo di rappresentare Dio, «le raffigurazioni della storia ebraica devono essere rispettose della privacy» – ha detto Noemi Di Segni, presidente di UCEI, e fare attenzione a fenomeni come il negazionismo e alle immagini che fanno apparire l’ebreo colpevole di orrori. «La sfida per gli studenti e gli insegnanti è capire come e quando credere alle immagini e come distinguere quelle vere da quelle false».
Le “immagini nonostante tutto” sono oggetto di un ampio dibattito che dal 1945 in poi non si è mai esaurito. Se la Shoah è l’indicibile, l’inimmaginabile, si può rappresentare? «Le foto dei campi di concentramento sono diventate il simbolo della possibilità o meno di rappresentare l’indicibile» – ha detto Milena Santerini, docente dell’Università Cattolica e vice presidente Fondazione Memoriale della Shoah. Si può anche non vedere nulla, come nel film Shoah di Claude Lanzmann dove l’orrore è rappresentato solo dagli sguardi dei sopravvissuti, oppure pensare che le immagini possano dire qualcosa, come sostiene lo storico dell’arte e filosofo Georges Didi-Huberman. In ogni caso la certezza è che «lo sterminio vero e proprio non si potrà mai vedere, perchè i nazisti distrussero tutte le prove, gli edifici, gli archivi, disseppellirono e bruciarono i cadaveri – ha continuato Santerini –. D’altra parte, la Shoah pur essendo del tutto reale, fatta di persone, nomi, cifre e storie, è in un certo senso invisibile per la tragicità che evidenzia».
È fondamentale fare riferimento a un’etica del “vedere” perché c’è sempre secondo la professoressa «il rischio del realismo esibito, del compiacimento e della morbosità che toglie dignità alle persone», ovvero la pornografia dell’orrore.
La rappresentazione è indispensabile per evitare di cadere nel pretesto dell’indicibile e del silenzio, così come lo è la parola. Diceva Primo Levi che “non dobbiamo scrivere come se fossimo soli. Abbiamo una responsabilità, finché viviamo: dobbiamo rispondere di quanto scriviamo, parola per parola e far sì che ogni parola vada a segno”.
Come scegliere se sostenere lo sguardo di fronte a certe immagini o distoglierlo? La propaganda nazista mirava a degradare gli ebrei riducendoli a nemici nemmeno degni di essere annoverati tra gli esseri umani. Vedere uomini umiliati, affamati, sporchi, ridotti quasi allo stato animale è come cedere a un male osceno ostentato ed è meglio, quindi, non guardare perché mostra solo la brutalità umana e una condanna crudele.
Santerini spiega, però, che una fotografia ha anche il potere di risvegliare l’istinto di pietà e di solidarietà verso gli altri, aiutare a riconoscere il dolore, accorciando la distanza con chi soffre o muore anche oggi. La foto può creare prossimità e muovere alla compassione, ma solo dopo aver “disinnescato” la capacità di rifiuto, indifferenza e disagio. È possibile farlo sostenendo lo sguardo delle vittime, riconoscendole come esseri umani sofferenti. Franz Stangl, comandante a Treblinka, cercava di considerare “non umane” le vittime destinate al gas. Per riuscirci evitava di assistere alla svestizione e nel momento in cui erano nude per lui non erano più esseri umani.
Oggi il tema delle immagini si confronta necessariamente con il web con il rischio dell’assuefazione e del consumo passivo. Santerini mette in guardia perchè «le fotografie della Shoah corrono il rischio di trasformarsi in un “catalogo di un’infamia moderna senza confini, dove tutto si scontorna nell’inflazione delle immagini”. A questo si aggiungono, ha concluso la docente, la manipolazione e la distorsione digitali delle immagini realizzate per esempio da alcuni negazionisti al fine di minimizzare le condizioni disumane nei campi di concentramento, o la decontestualizzazione delle immagini dove fotografie autentiche vengono presentate con didascalie false o in contesti errati.
La questione delle immagini denigratorie riguarda molte minoranze – e gli stessi ebrei ben prima dell’epoca nazista – che nel tempo hanno sviluppato la capacità di insospettirsi e di interloquire con il potere politico per farle rimuovere. A questo proposito il professor Germano Maifreda dell’Università degli Studi di Milano ha portato un esempio di raffigurazione del nemico dell’Italia del Seicento relativo alla contestazione da parte della comunità ebraica di Mantova nel giugno del 1625 perché era stato esposto un quadro antisemita. La comunità, capace di elaborazione del trauma e di negoziazione con il potere politico, ha ottenuto la rimozione del quadro e ha realizzato una copia tramandata ai posteri che ha permesso la memoria e lo studio dell’accaduto.
Infine, Manuele Gianfrancesco, storico della Fondazione Museo della Shoah di Roma, ha raccontato l’intento della mostra “La fine dei Lager”, dove i curatori hanno evitato di mostrare le immagini più cruente senza ometterle, ma posizionandole in una sala con un panno nero per avvertire il pubblico dell’effetto che possono suscitare.