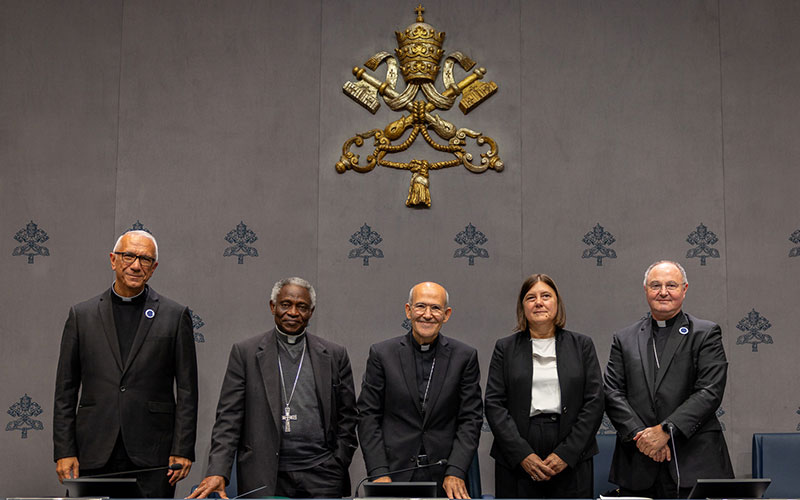Quello che stiamo compiendo è un gesto molto significativo per ciascuno di noi e per la comunità dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Abbiamo accolto l’invito, formulato nella Bolla di indizione, a vivere il Giubileo come occasione di conversione e di rinnovamento sia a livello personale sia come comunità accademica. Con questo Spirito ci siamo messi anche noi in cammino come pellegrini di speranza e abbiamo attraversato la Porta Santa nella consapevolezza che c’è «bisogno anche di momenti forti per nutrire e irrobustire la speranza, insostituibile compagna che fa intravedere la meta: l’incontro con il Signore Gesù» (Spes non confundit, n. 5). Viviamo questo evento di grazia con il vigore che ci infonde San Paolo, disposto addirittura ad essere separato da Cristo (anàtema) pur di vedere i fratelli di sangue ebrei entrare per la porta della salvezza.
Quello di attraversare la Porta Santa è un gesto semplice ma è carico di grandi significati se pensiamo che è il segno dell’incontro con la persona stessa di Gesù che si prende cura delle sue pecore. «Io sono la porta - leggiamo nel Vangelo di Giovanni -: se uno entra attraverso di me sarà salvato; entrerà e uscirà e troverà pascolo» (Gv 10,9). Questo gesto ci ricorda che attraversando l’unica porta che conduce alla verità e alla pienezza della vita in Cristo, possiamo dare senso compiuto a tutte le porte che ogni giorno attraversiamo nella nostra vita, sapendo scegliere quelle strette della carità e del servizio (cfr. Lc 13,24). In esse possiamo riconoscere i tanti passaggi che nel percorso della nostra vita e nell’esperienza di ogni giorno ci fanno sperimentare la fatica e la bellezza di dimorare in Dio. Sono infatti molte le porte che siamo chiamati ad attraversare ogni giorno con il Signore.
C’è la porta del cuore che ci consente di aprire il nostro intimo al Signore e di sviluppare quei sentimenti che ci fanno gustare la bellezza di stare con il Signore e di abitare il mistero del suo amore. «Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù» (Fil 2,5) afferma San Paolo introducendo l’inno cristologico con cui invita i Filippesi a conformarsi a Cristo povero e servo. Sono sentimenti che nascono da una profonda conversione del cuore e si traducono in atteggiamenti concreti e profetici come quelli ampiamente descritti dall’apostolo delle genti nella lettera ai Romani: «La carità non sia ipocrita: detestate il male, attaccatevi al bene; amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno, gareggiate nello stimarvi a vicenda. Non siate pigri nel fare il bene, siate invece ferventi nello spirito; servite il Signore. Siate lieti nella speranza, costanti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera. Condividete le necessità dei santi; siate premurosi nell'ospitalità» (Rm 12,9-13). Quanto è difficile vivere con questi sentimenti in una società segnata dall’individualismo e dall’egoismo! Per questo abbiamo bisogno di una continua conversione, di un permanente stile giubilare ricordandoci delle parole del Signore che risuonano nell’Apocalisse: «Ecco: sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me» (Ap. 3,20.
C’è poi la porta degli affetti e dei legami attraverso cui si esprime il senso profondo della nostra esistenza. Molteplici e diversi sono le relazioni che danno forma alla nostra vita: da quelli più profondi maturati nella realtà familiare a quelli più diversi che si manifestano nelle amicizie fino ai tanti rapporti sociali che ci vedono impegnati nella costruzione del bene comune. Porte esistenziali che attraversiamo ogni giorno, cariche di aspettative e speranze ma segnate anche da delusioni, amarezze e sofferenze. Siamo qui per ripensare anche alla bellezza e alla fatica di tenere le porte aperte anche di fronte alla tentazione di chiuderle. Essere pellegrini di speranza significa, da una parte, aprire sempre con coraggio e decisione la porta al bene e, dall’altra, di chiuderla con fermezza al male secondo il monito dell’Angelo alla Chiesa di Filadelfia: «Così parla il Santo, il Veritiero, Colui che ha la chiave di Davide: quando egli apre nessuno chiude e quando chiude nessuno apre. Conosco le tue opere. Ecco, ho aperto davanti a te una porta che nessuno può chiudere» (Ap. 3,7-8).
In terzo luogo, per noi oggi è utile anche riflettere sulla porta dell’Ateneo. È l’ambiente dove il Signore ci ha chiamato concretamente a fare esperienza del suo amore e del suo disegno di salvezza, ciascuno secondo il proprio ruolo, professori, studenti e personale tecnico-amministrativo. È bello ritrovarci qui assieme dopo aver attraversato la Porta Santa e aver ascoltato il successore di Pietro nel contesto del Giubileo del mondo dell’educazione, mentre celebriamo il 60° della Dichiarazione conciliare Gravissimum educationis (28 ottobre 1965). Molte porte si sono aperte per la nostra Università, in oltre cento anni di storia, grazie alla fede, all’intelligenza e alla passione di tutti coloro che, a partire dai nostri fondatori, P. Agostino Gemelli e la Beata Armida Barelli, fino ai nostri giorni, hanno tenuta spalancata con fede e coraggio la porta di Cristo sulla ricerca costante della verità, sul servizio allo sviluppo sociale nei diversi campi del sapere e dell’agire umano, sulla sfida educativa per dare in ogni stagione alle nuove generazione gli strumenti utili per essere protagonisti di una società più giusta, accogliente e pacifica.
Oggi qui, sulla Cattedra di San Pietro, rinvigoriamo la nostra speranza e rinnoviamo il nostro impegno per rendere l’Ateneo dei cattolici italiani uno strumento sapiente ed efficace per la missione della Chiesa nel nostro tempo. Facciamo nostro lo Spirito e lo stile indicato da Papa Leone nella lettera Apostolica per il 60° della Gravissimum Educationis: «siate servitori del mondo educativo, coreografi della speranza, ricercatori infaticabili della sapienza, artefici credibili di espressioni di bellezza. Meno etichette, più storie; meno sterili contrapposizioni, più sinfonia nello Spirito. Allora la nostra costellazione non solo brillerà, ma orienterà: verso la verità che rende liberi (cfr. Gv 8,32), verso la fraternità che consolida la giustizia (cfr. Mt 23,8), verso la speranza che non delude (cfr. Rm 5,5)» (Leone XIV, Lettera apostolica, Disegnare nuove mappe di speranza, [27 ottobre 2027], n. 11.3).
Perché questo si realizzi abbiamo bisogno di essere continuamente e profondamente risanati, come evidenziato anche nel Vangelo odierno. Gesù smaschera l’ipocrisia dei Farisei, ma soprattutto vuole ricordare a tutti i credenti che abbiamo bisogno della sua grazia per essere guariti. E nel campo della formazione accademica serve una grazia speciale. «Questa è la grazia dello studente, del ricercatore, dello studioso - afferma Leone XIV -: ricevere uno sguardo ampio, che sa andare lontano, che non semplifica le questioni, che non teme le domande, che vince la pigrizia intellettuale e, così, sconfigge anche l’atrofia spirituale» (Omelia, 27 ottobre 2025). Per avere una visione così ampia dobbiamo alzare lo sguardo, cambiare il nostro punto di vista, assumere un’altra prospettiva, operazione che solo la fede può consentire.
C’è, infine, un’ultima porta, la più importante che non dobbiamo mai perdere di vista; è quella del Cielo, da cui le cose si vedono in modo diverso e sempre nuovo. Lo ricorda San Giovanni nell’Apocalisse: «Poi vidi: ecco, una porta era aperta nel cielo. La voce, che prima avevo udito parlarmi come una tromba, diceva: "Sali quassù, ti mostrerò le cose che devono accadere in seguito”» (Ap 4,1). Non stanchiamoci allora di attraversare con Cristo le tante porte dell’esistenza lasciandoci illuminare dalla luce che già filtra dalla porta ultima e definitiva. E mentre come veri pellegrini alziamo gli occhi al cielo lavoriamo insieme, intensamente e in modo creativo, per tracciare ogni giorno quelle “mappe di speranza” indicate da Papa Leone perché «così, l’educazione cattolica diventa lievito nella comunità umana: genera reciprocità, supera riduzionismi, apre alla responsabilità sociale. Il compito oggi è osare un umanesimo integrale che abiti le domande del nostro tempo senza smarrire la sorgente» (Leone XIV, Lettera apostolica, Disegnare… cit., n. 6.2). Amen.