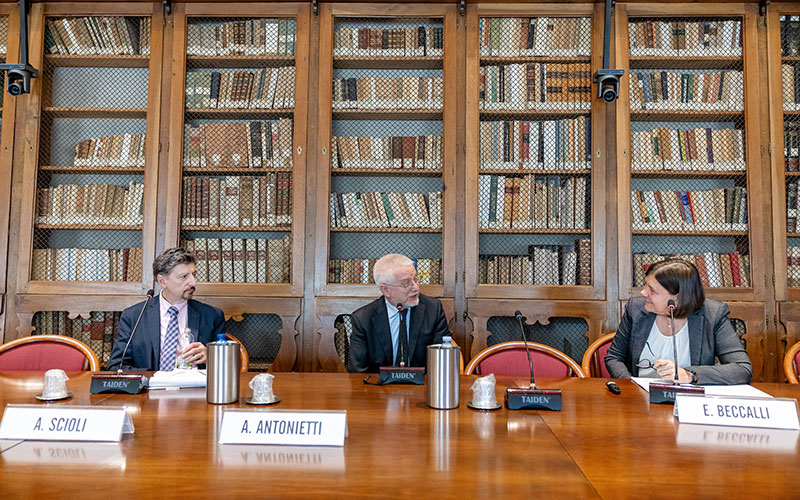Si potrebbe istintivamente pensare che la “paghetta”, ovvero la regolare disponibilità di denaro da gestire in autonomia da parte dei minori possa essere sempre il modo migliore per invitarli a un comportamento responsabile. In realtà, le cose non stanno proprio così, come mostra una ricerca coordinata da Edoardo Lozza, docente di Psicologia dei consumi e del marketing e di Psicologia economica all’Università Cattolica di Milano.
«Su un campione rappresentativo di adolescenti abbiamo analizzato se e come le modalità con cui ricevono soldi dai genitori (per esempio, paghetta settimanale o mensile, oppure a richiesta di volta in volta), nonché l’entità del denaro a loro disposizione, possano prevedere comportamenti a rischio per la salute, come fumo, alcol, droghe, gioco d’azzardo - ha dichiarato il professore -. Con una certa sorpresa, i risultati mostrano che una modalità “fissa” di ricevere denaro dai genitori (paghetta), insieme a una disponibilità più elevata (oltre i dieci euro settimanali), si associa a un rischio maggiore di mettere in atto i comportamenti a rischio. Al contrario, un fattore protettivo sembra essere la modalità di richiedere denaro ai genitori di volta in volta, insieme (ma questo è meno sorprendente) a una cifra più contenuta di denaro a disposizione».
Sono i risultati principali di uno studio che, in una collaborazione tra l’Unità di Ricerca in Psicologia Economica dell’Università Cattolica e l’Istituto Mario Negri di Milano, è stato recentemente pubblicato sugli Annali dell’Istituto Superiore di Sanità a partire dai dati dello studio Health Behaviour in School-aged Children (HBSC), un'indagine transnazionale coordinata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.
I dati raccolti riguardano un campione di 989 studenti di 15 anni e l’analisi ha riguardato in particolare cinque comportamenti a rischio, ovvero il fumo e l’assunzione di alcol negli ultimi 30 giorni, il binge drinking (cioè la consuetudine ad assumere alcolici fino a ubriacarsi), il consumo di cannabis e il gioco d’azzardo, mettendoli in relazione con la disponibilità di denaro per uso personale e le modalità di ricezione (paghetta settimanale o “al bisogno” dietro richiesta ai genitori).
Un’evidenza emersa nella popolazione analizzata è la relazione statisticamente significativa tra la disponibilità di denaro e il fumo. Infatti, è risultata più elevata la presenza di fumatori tra gli adolescenti che spendevano più di 10 euro a settimana. Interessante, poi, è anche il rapporto tra la modalità di accesso al denaro e il fumo: tra gli adolescenti che ricevevano la paghetta erano più frequenti i fumatori, non così nel caso della ricezione di denaro su richiesta. Inoltre, gli adolescenti che ricevevano meno di 10 euro “al bisogno” e su richiesta a settimana avevano una minore probabilità di essere fumatori, di sperimentare il binge-drinking e di giocare d’azzardo.
L’importo di 10 euro (indipendentemente dalla modalità di accesso al denaro) nel 2018 sembrava essere la soglia oltre la quale la probabilità di assumere comportamenti dannosi aumentava, e in particolare la disponibilità di una paghetta settimanale era associata ad una maggiore propensione ad assumere almeno quattro dei cinque comportamenti a rischio esaminati.
Interrogandosi sulle motivazioni che hanno portato a questi risultati, si può considerare che «la richiesta di denaro ai genitori implica spesso chiarire i motivi della stessa e questo potrebbe tradursi in una sorta di pre-impegno assunto dagli adolescenti coi genitori - ha specificato Lozza -. In secondo luogo, si può ipotizzare che l'assenza di una regolare erogazione di denaro possa indurre gli adolescenti a sentire una maggiore responsabilità per il denaro richiesto, considerato non come un diritto ma come un modo di far parte della gestione e dell'equilibrio familiare».
In effetti, come hanno suggerito alcuni ricercatori in studi condotti in passato, il pagamento regolare delle “mance” potrebbe indurre bambini e adolescenti a fare eccessivo affidamento sui genitori promuovendo la dipendenza finanziaria piuttosto che la capacità di gestione. Infine, l’atto di associare la paghetta a un servizio reso, come le faccende domestiche, apre alla negoziazione sul denaro e alla mentalità “comunitaria” e solidale fondamentale nel processo di socializzazione finanziaria e al bene comune familiare.
Informare i genitori e gli operatori sanitari di questi rischi e opportunità potrebbe mettere al riparo da impatti negativi sugli adolescenti.
A margine di questa ricerca, è doveroso evidenziare che in Italia la gestione del denaro è considerata ancora un tabù di fronte ai figli e l’educazione finanziaria molto poco diffusa.
Con la buona intenzione di proteggere i bambini dalle stesse preoccupazioni degli adulti e di non creare fraintendimenti, i genitori non abituano i ragazzi a parlare delle questioni economiche che sono invece parte della vita quotidiana.
A ciò si aggiungono i pregiudizi di genere, come è emerso da un altro studio tra soggetti adulti, condotto dalla psicologa dell’Università Cattolica Claudia Manzi, su “Donne e denaro: una sfida per l’inclusione”. Colmare il divario di genere nell’alfabetizzazione finanziaria è indubbiamente una priorità per raggiungere la parità nelle opportunità relative alle pratiche di investimento e ai conseguenti livelli di benessere finanziario.
I risultati di questa ricerca mostrano, inoltre, che anche la financial literacy “soggettiva” (cioè quanto le persone pensano di sapere in ambito finanziario, indipendentemente dalle conoscenze “oggettive” realmente possedute) è molto più bassa fra le donne rispetto agli uomini e questo vale sorprendentemente anche per le donne con studi economici alle spalle.
«Nello studio sugli adolescenti e la paghetta non abbiamo trovato particolari differenze fra maschi e femmine - ha specificato Lozza -: questo da un lato può far ben sperare che il “gender gap” si stia riducendo presso le nuove generazioni, anche se permangono troppi stereotipi di genere e troppi tabù sul denaro e sulla sua gestione».
Ma quello della “psicologia del denaro” è il tema di un altro libro del professore per i tipi di Vita e Pensiero in uscita il prossimo autunno.
Foto di Tobias Tullius su Unsplash