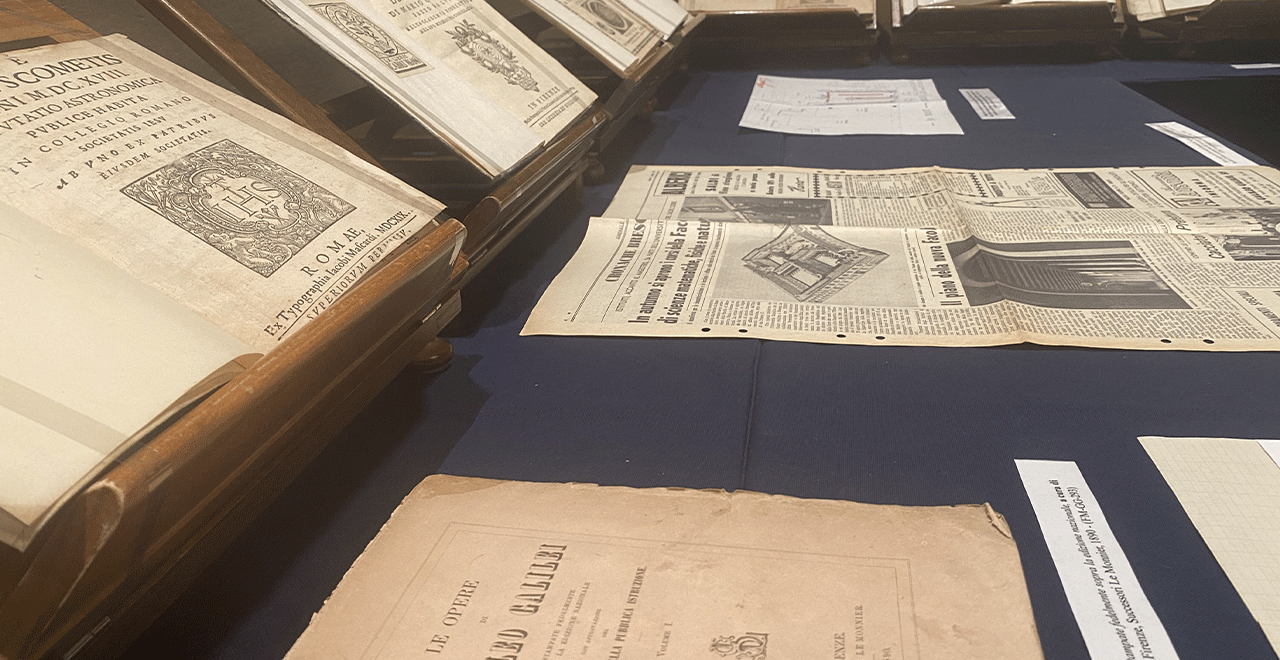I libri sono vivi, dinamici e dobbiamo solo renderli attivi. In quale modo lo aveva ben chiaro l’’ing. Carlo Viganò quando decise, cinquant’anni fa, con lungimirante generosità, anche per il valore economico dei volumi, di non lasciare fra le mura di casa la raccolta di circa 10.000 volumi di materia scientifica, che comprende manoscritti, incunaboli, cinquecentine e edizioni dal XVII al XIX secolo.
Un tesoro che ha donato all’Università Cattolica dando così vita alla Biblioteca di Storia delle scienze affinché docenti, studenti e studiosi potessero consultare prime o rare edizioni dei più eminenti scienziati della storia a partire da Archimede, Euclide, Apollonio di Perga, giungendo a Niccolò Copernico, Galileo Galilei, Giovanni Keplero, Isaac Newton, passando per i bresciani Niccolò Tartaglia, Benedetto Castelli e Francesco Lana de’ Terzi.
Una raccolta che lasciato stupito uno dei massimi studiosi delle opere di Galileo Galilei, il prof. Michele Camerota, docente all’Università di Cagliari, intervenuto in Cattolica il 3 maggio per ricordare il cinquantesimo anniversario della donazione. «Non è facile trovare tutti insieme così tanti documenti di Storia delle scienze a partire dal 500. Qui è custodita anche una ricca raccolta della bibliografia di Antonio Favaro, in larghissima misura dedicata a Galileo, che indaga ogni aspetto della vita e dell’opera dello scienziato pisano e accompagna, per gran parte, la realizzazione di un vero e proprio capolavoro editoriale: l’Edizione Nazionale delle Opere di Galileo. Una nuova e “definitiva” edizione delle Opere galileiane, che si proponeva di ovviare alle lacune e ai difetti della cosiddetta “prima edizione completa”, pubblicata in sedici tomi da Eugenio Albèri tra il 1842 e il 1856».
Camerota ne ripercorre la storia, la metodologia usata, la severa “impersonalità” con un assetto esclusivamente documentario che ha contribuito a sottrarre la figura di Galileo alle distorsioni e agli stravolgimenti operati nell’ambito dell’aspra disputa allora in corso tra laici e cattolici, i quali, entrambi, rivendicavano alla propria causa il magistero galileiano. A lavoro completato, Antonio Favaro avrà modo di sottolineare come l’Edizione Nazionale, nella sua “neutralità”, potesse favorire un dibattito tra le opposte fazioni meno ideologico e strumentale, nonché più storicamente attendibile.
Libri antichi, carteggi, che vanno riletti e interpretati alla luce di nuove scoperte, come hanno ricordato nei saluti introduttivi del coordinatore delle strategie di sede Mario Taccolini, il preside di Scienze matematiche Maurizio Paolini e il direttore di sede Giovanni Panzeri, ripercorrendo le tappe che hanno portato all’istituzione della Biblioteca delle Scienze Carlo Viganò. Una presenza divenuta familiare a chi ogni giorno lavora accanto a questi preziosi volumi come al responsabile della biblioteca di sede Pierangelo Goffi e al collaboratore Diego Cancrini che ha proposto una ricostruzione documentaria del percorso che portò la Biblioteca Viganò in Università, nel periodo intercorso tra la manifestazione della volontà dell’ingegnere (agosto 1971) e l’effettiva donazione con il conseguente arrivo della stessa a destinazione (tra l’aprile e il tardo autunno 1973).
Come ogni tesoro va custodito, ma non nascosto e un’altra studiosa che sovente trascorre parte del suo tempo fra le carte e i libri della Viganò è Simona Gavinelli, docente di Paleografia in Cattolica. La ricercatrice ha mostrato i risultati del proseguimento delle sue ricerche sul “Fondo Autografi”. I nuovi documenti, conservati in faldoni non ordinati, includono autografi di importanti uomini di scienza tra il XVIII e il XIX secolo, tra i quali Pietro Caldani, Baldassarre Boncompagni Ludovisi e Angelo Secchi. «Le nuove lettere o meglio i nuovi autografi nel senso lato, sono emersi continuando a compulsare altri faldoni in cui erano stipati, in maniera disorganica materiali vari, anche a stampa e ho costruito una serie di testimonianze sulla figura di Galileo, quali ad esempio quella del 1843 di Baldassarre Boncompagni Ludovisi, il primo storico delle origini della matematica e dell’algebra, che aveva impegnato ingenti capitali per crearsi una vasta biblioteca scientifica di manoscritti e stampati».
E le donne? Quale formazione scientifica avevano verso la metà del XVIII secolo? Il ricercatore Marco Zanini ha offerto una panoramica delle teorie sull’educazione femminile circolate a Brescia e in tutta la Repubblica veneta, con particolare attenzione delle dame bresciane Giulia Baitelli, Camilla Solar d’Asti, Lodovica Fè e Diamante Medeglia.
Un libro che ancora oggi può essere considerato un capolavoro di scrittura, con una prosa scintillante, ancorata al rigore scientifico delle argomentazioni è il Saggiatore di Galileo Galilei, pubblicato 400 anni fa e presente in una prima edizione nella Viganò.
«Nessuna opera meglio del Saggiatore ci aiuta a capire la concezione che Galileo aveva della scienza» spiega Franco Giudice, docente di Storia della scienza in Cattolica, assiduo e appassionato studioso delle preziosi volumi della Viganò da oltre vent’anni.
Per questo è utile ripercorrere l’origine di questa opera, nata - come spiega Giudice - dalla disputa con il gesuita Orazio Grassi sulla natura delle comete apparse nei cieli autunnali del 1618, ma che esprime la piena consapevolezza della portata rivoluzionaria del nuovo sapere, inaugurato dallo stesso Galileo con le straordinarie scoperte telescopiche del 1610, quando aveva ridisegnato la geografia del mondo ed esteso i confini dell’universo.
È nel Saggiatore che Galileo espone la sua celebre dottrina secondo cui la natura è dotata di un ordine e di un’armonia di tipo geometrico, che va quindi letta come un libro. Non un libro di quelli scaturiti dalla fantasia dei poeti, ma un libro scritto in linguaggio geometrico, che può essere compreso soltanto da chi è in grado di “conoscer i caratteri, ne’ quali è scritto” (triangoli, cerchi, etc.)”.
In particolare, il prof. Giudice si è soffermato sulla Favola dei suoni, uno dei testi più famosi del Saggiatore. Giacomo Leopardi, infatti, lo inserì tra gli apologhi nella sua Crestomazia della prosa italiana (1827), con il titolo “La generazione dei suoni. La favola descrive il singolare viaggio di “un uomo dotato da natura d’uno ingegno perspicacissimo e d’una curiosità straordinaria”, che alleva uccelli per dilettarsi del loro canto e che poi cerca di comprendere i vari modi in cui si generano i suoni, a partire da quello delicato emesso dallo strumento suonato da un pastorello, uno zufolo, fino all’“altissimo stridore” prodotto da una cicala».
Secondo Galileo – conclude Giudice - è vano cercare di sottomettere la varietà dei fenomeni naturali a schemi aprioristici, ma anche che le dimostrazioni matematiche ci permettono di conoscere perfettamente una sola cosa, mentre la conoscenza della ricchezza e della complessità della natura sarà sempre un lavoro in divenire.