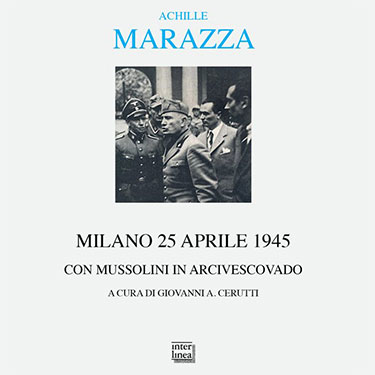In questi giorni, entrando nella cappella della sede milanese dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, si nota sulla sinistra un piccolo quadro raffigurante il volto di Gesù in Croce. Bisogna però soffermarsi un attimo e leggere la breve nota riportata sotto per capire che non si tratta di una delle molte raffigurazioni della Passione di Cristo. La storia di questa immagine ci costringe, infatti, a fare i conti nuovamente con una delle pagine più buie del nostro passato comune.
Il disegno fu realizzato da un prigioniero di un lager nazista. Il suo nome era Mario Morgante. Di professione architetto, originario di Trieste, Morgante viveva a Milano quando fu arrestato per le sue convinzioni antifasciste. Rinchiuso nel carcere di San Vittore, fu poi condotto ad Ebensee in Austria. Questa placida località nascondeva durante la Seconda Guerra Mondiale, tra i boschi attorno al suo pittoresco lago, uno dei tanti teatri dell’orrore nazista. Costruito come succursale di quello di Mauthausen, il campo di concentramento di Ebensee divenne tristemente noto per le terribili condizioni in cui erano tenuti i prigionieri, tra i quali vi furono molti italiani, puniti con la deportazione e i lavori forzati per essersi rifiutati di collaborare con le forze di occupazione tedesche.
È facile immaginare che dovettero essere proprio le sofferenze che Morgante subì e che vedeva attorno a sé a ispirargli la scelta del soggetto, che realizzò con i poveri materiali che aveva a disposizione: carbone, calce e un piccolo foglio di cartone come tela. Possiamo anche credere che fu proprio il desiderio di condividere i suoi più intimi sentimenti, condensati in quella figura sacra tanto potente, a suggerirgli di donare il disegno al suo compagno di prigionia, Franco Ferrante, magistrato, anche lui arrestato a Milano per la sua fede politica.
Il ritratto del volto di Cristo rimase appeso alla parete della baracca dove viveva Ferrante, fino a quando un ufficiale delle SS non lo notò e ne ordinò la distruzione. A quel punto Morgante riuscì a riprenderlo e conservarlo fino alla liberazione. Non ci è dato di conoscere come esattamente poté salvarsi il disegno e, del resto, questo non è il solo dettaglio poco chiaro, anche se va detto che le lacune non compromettono il profondo significato che traspare in controluce dai fatti.
Da quanto si è riusciti a ricostruire, finita la guerra, Morgante regalò il quadro a un’asta di beneficenza per gli ex deportati e le loro famiglie. Sui banchi di una bancarella, il disegno venne notato da Aldo Carpi, direttore dell’Accademia di Brera, altro grande personaggio la cui storia meriterebbe di essere raccontata a parte. Qui basti ricordare che, a sua volta, Carpi aveva annotato con alcuni drammatici tratti di carboncino i momenti più dolorosi della sua prigionia in un altro campo austriaco, quello di Gusen.
Visto il quadro, Carpi decise di comprarlo e regalarlo a Ferrante, di cui era amico. Questo è tutto quello che sappiamo. Rimangono, quindi, purtroppo senza risposta molte domande. Che cosa destò la curiosità dell’artista e maestro di molti altri pittori? Che cosa lo mosse all’acquisto e poi successivamente al dono in favore proprio di Ferrante? Purtroppo, possiamo fare solo alcune congetture. Per esempio, possiamo ritenere che Carpi avesse rivisto in quel quadro — e nelle circostanze della sua realizzazione, che poteva immaginare — la propria stessa angosciosa esperienza, e quindi, mosso da quei ricordi, lo volle comprare ed esporre a casa sua, dove l’amico Ferrante lo riconobbe.
Oppure, più semplicemente, possiamo credere che Carpi fosse a conoscenza di questa storia e, letta la firma in calce al disegno, lo avesse acquistato per restituirlo al legittimo proprietario.
Comunque siano andate le cose, resta in ogni caso la potenza di quel simbolo, il volto di Cristo morente, in cui i protagonisti della vicenda riuscirono a vedere rispecchiato il proprio personale dolore e a trasfigurarlo in qualcosa d’altro che parla, attraverso le generazioni, anche a noi.
Tornato in possesso del disegno, Ferrante lo custodì tra i suoi ricordi più preziosi. Alla sua morte, la nipote, Francesca Lodi, lo ereditò insieme ad altri oggetti personali che lo zio, nel testamento, le chiese di custodire: una lettera alla famiglia scritta nel ’44 dal carcere di San Vittore e alcune foto scattate dallo stesso Ferrante a Ebensee, nel corso di un viaggio che aveva fatto finalmente da uomo libero.
Il quadro, donato da Francesca Lodi all’Associazione Nazionale Ex Deportati nei campi nazisti (ANED), è stato esposto per la prima volta nel 2024 a Prato, in ricordo dei cittadini deportati a Ebensee dopo gli scioperi del marzo 1944. In occasione dell’ottantesimo anniversario della Liberazione, quest’anno l’opera è visibile nella cappella dell’Università Cattolica in largo Gemelli a Milano nel periodo pasquale e poi fino al 4 maggio, grazie all’iniziativa del professor Andrea Canova, preside della Facoltà di Lettere e Filosofia, e della professoressa Raffaella Perin, docente di Storia del cristianesimo.