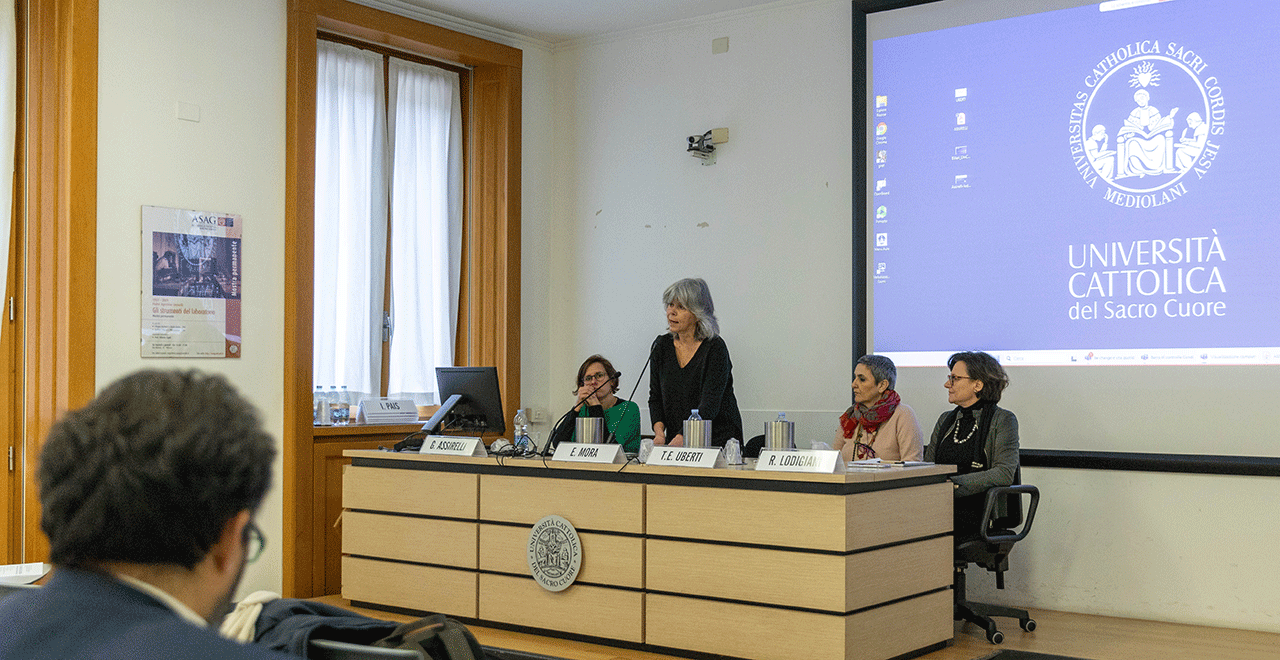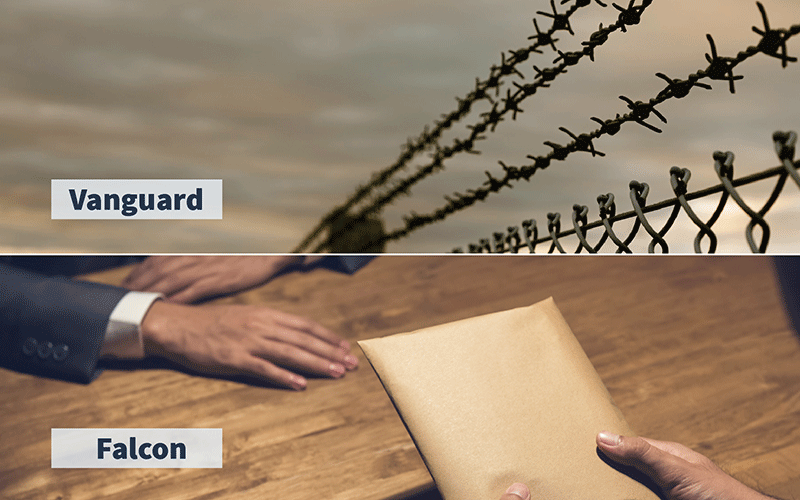Dalla pandemia a oggi circa il 30% della popolazione italiana ha aumentato l’uso di internet per il tempo libero, la diffusione di comportamenti sostenibili nella vita quotidiana e il tempo trascorso in casa. Un cambiamento che ha riguardato in modo disomogeneo la popolazione, in particolare i giovani più degli anziani, gli uomini più delle donne, gli abitanti delle città più densamente popolate rispetto alle altre.
Un'ampia ricerca condotta dall'Università Cattolica del Sacro Cuore, intitolata "Behavioural Change: Prospettive per la stabilizzazione di comportamenti virtuosi verso la sostenibilità", ha analizzato l'impatto duraturo della pandemia da COVID-19 sulle abitudini degli italiani. Presentato oggi nel campus milanese in largo Gemelli 1 nel convegno finale, lo studio ha coinvolto un campione di 4576 persone (2021 nella prima rilevazione, 2555 nella seconda), la cui distribuzione per genere, età, titolo di studio e condizione occupazionale rispecchia quella della popolazione italiana residente. I due campioni sono stati interpellati in due occasioni (giugno 2021 e giugno-luglio 2023) per valutare i cambiamenti comportamentali sia durante sia dopo l'emergenza sanitaria.
Le principali evidenze
I risultati mettono in luce una complessa realtà. Da un lato, si sono registrati cambiamenti strutturali significativi in alcuni ambiti, come l'aumento nell'utilizzo di internet per lavoro e svago e l'adozione di comportamenti più sostenibili.
Dall'altro, la diffusione di queste modifiche è risultata meno pervasiva del previsto. Si osserva una disomogeneità nella popolazione, con differenze legate a fattori socio-demografici come età, livello di istruzione, condizione economica e area geografica.
• L'utilizzo di internet, per lavoro o tempo libero, è aumentato in modo strutturale (rispettivamente +23% e 37%), ma con differenze significative tra fasce d'età e livelli di istruzione: ad esempio, il 36% dei laureati ha aumentato strutturalmente l’utilizzo di internet per lavoro contro il 18% dei meno istruiti e le percentuali salgono rispettivamente a 43% e 32% per l’utilizzo del web nel tempo libero.
• I comportamenti sostenibili si sono consolidati, con 3 intervistati su 10 che dichiarano di averne aumentato l’adozione in maniera strutturale. La loro adozione rimane disomogenea sul territorio nazionale: nelle grandi e medie città circa un intervistato su tre dichiara di aver aumentato in maniera strutturale l’adozione di comportamenti sostenibili, mentre la percentuale è del 17% nelle zone meno densamente popolate, e questa differenza è particolarmente marcata nelle regioni del Sud.
• Le spese nei negozi di vicinato e per ristorazione hanno subito una diminuzione strutturale (-15% e -43%), soprattutto tra chi ha scarse condizioni economiche (rispettivamente -19% e -51%).
• Il tempo trascorso in casa è aumentato in modo strutturale per oltre un intervistato su tre. Ad aver incrementato le ore trascorse tra le mura domestiche sono soprattutto coloro che hanno condizioni economiche precarie (+45%) e i non occupati (+43%).
I ricercatori hanno effettuato approfondimenti su due campioni indipendenti della prima e della seconda wave, in particolare relativi all’uso di internet per il tempo libero e all’adozione di comportamenti sostenibili. Riguardo il primo, la ricerca evidenzia che la pandemia ha accelerato il processo di mutamento, favorendo l’utilizzo di internet per molte attività del tempo libero, un cambiamento nel post pandemia. Le voci analizzate riguardano il fare la spesa, l’acquisto di abbigliamento, cosmesi e pasti, la lettura, la prenotazione degli alberghi, la fruizione dei film, i videogiochi, il gioco d’azzardo e il dating online.
In secondo luogo, dallo studio emerge che la pandemia ha accelerato il processo di adozione di comportamenti sostenibili nella vita di tutti i giorni, complice probabilmente il confinamento forzato tra le mura domestiche che ha portato e ripensare alcuni comportamenti, rinforzati nel periodo post-pandemico. Come il bere l’acqua dal rubinetto, l’uso più parsimonioso dei fogli di carta, l’utilizzo dei detersivi ecologici, l’acquisto di prodotti sfusi e a kilometro zero, la preferenza dell’usato al nuovo, il minore consumo di carne e la raccolta differenziata.
«La pandemia ha agito come uno shock esogeno che ha accelerato trasformazioni già in atto, ma la sua influenza sulla popolazione è stata disomogenea. Questo evidenzia la necessità di politiche mirate a favorire l'adozione di comportamenti virtuosi e a ridurre le disuguaglianze» – hanno affermato Emanuela Mora e Mario A. Maggioni, coordinatori della ricerca.