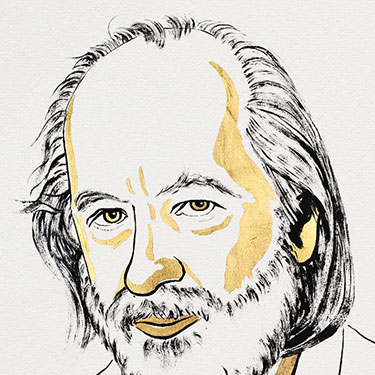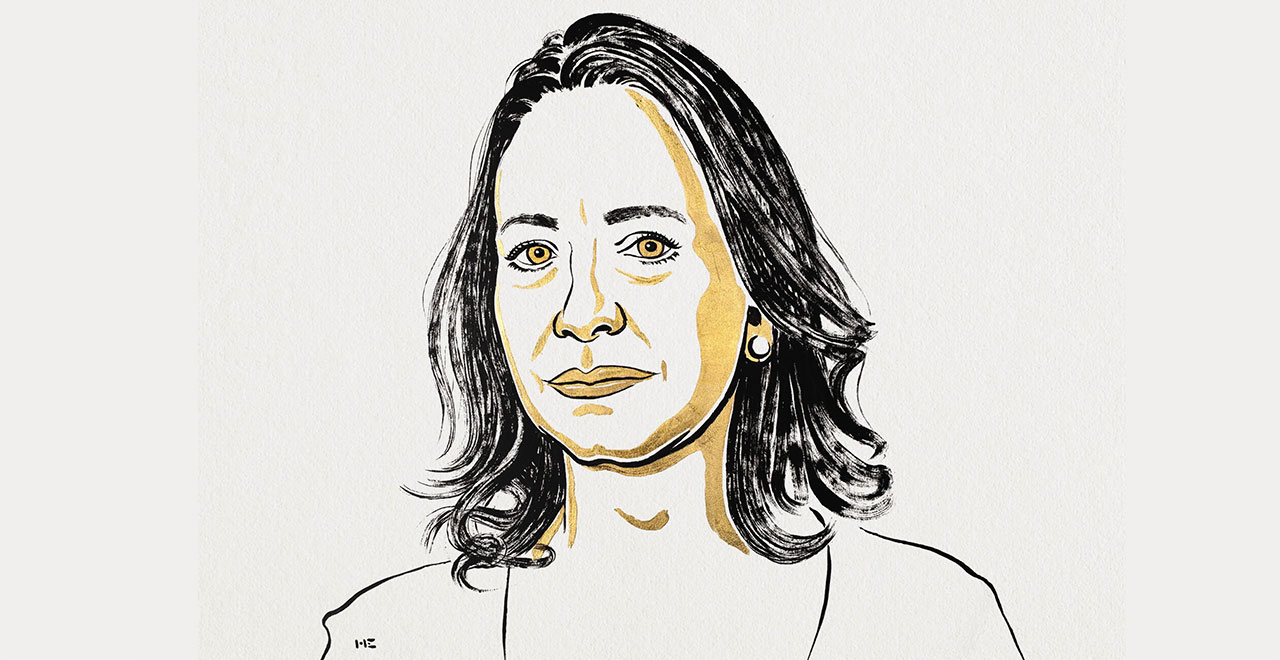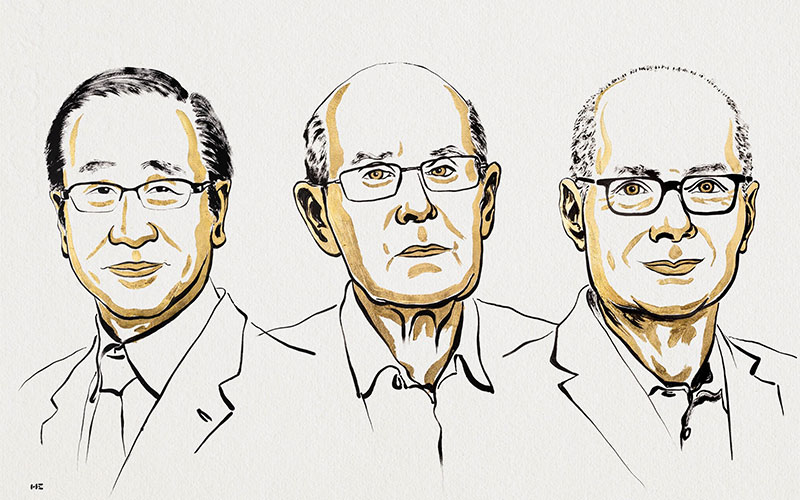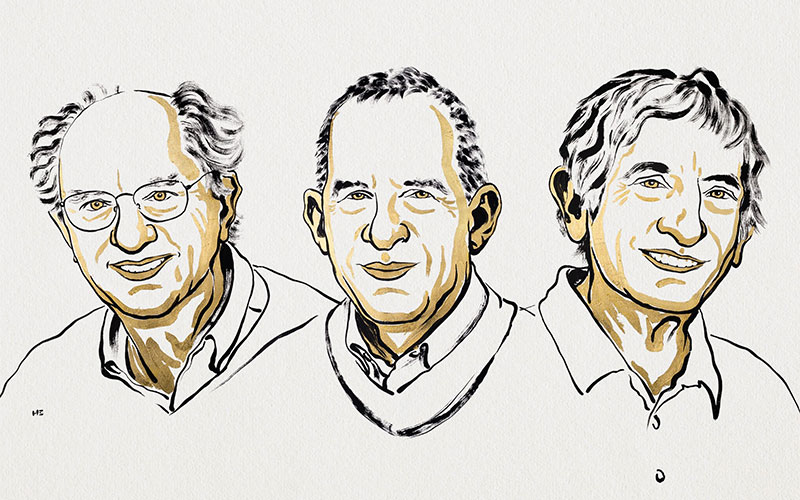Il Comitato norvegese ha assegnato il Premio Nobel per la Pace 2025 a Maria Corina Machado "per il suo lavoro nella promozione dei diritti democratici e per la sua lotta per raggiungere una transizione giusta e pacifica dalla dittatura alla democrazia in Venezuela". Commenta il premio Ignacio Fernando Lara di ASERI - Alta Scuola in Economia e relazioni internazionali dell''Università Cattolica.
Il recente conferimento del Premio Nobel per la Pace a María Corina Machado ha acceso un intenso dibattito, gettando luce sia sullo straordinario coraggio di una persona che resiste all’autoritarismo, sia sulle profonde fratture che caratterizzano le società contemporanee. L’opposizione incrollabile di Machado al regime venezuelano - che da tempo ha abbandonato anche i requisiti minimi della democrazia - l’ha portata a subire persecuzioni e alla migrazione forzata. In questo contesto, il riconoscimento sottolinea il desiderio umano persistente di libertà e responsabilità.
Chi è Maria Corina Machado | Il ritratto di Andrés Malamud
Tuttavia, questo premio mette anche in evidenza i dilemmi del vivere in società profondamente polarizzate, dove ogni azione è interpretata attraverso lenti ideologiche radicate e inconciliabili. L’ammirazione per la lotta di Machado contro la dittatura si sfuma di fronte al suo allineamento con – e al sostegno ricevuto da – attori reazionari di destra, sia nel Nord che nel Sud globale, che instancabilmente minano i pilastri della democrazia e del pluralismo. Ugualmente sorprendente è il silenzio, o la condanna tardiva, di molti governi progressisti, che hanno fallito nel denunciare con fermezza il regime venezuelano, spesso a causa delle sue origini nominalmente di sinistra ormai da tempo tradite.
Queste dinamiche mettono in luce le ambiguità etiche delle alleanze politiche e la difficoltà di sostenere i valori democratici in un mondo in cui la polarizzazione distorce la chiarezza morale. Spiegano anche gli schieramenti rigidi e le alleanze forzate che si fondano sulla dicotomia schmittiana amico-nemico, piuttosto che su valori e principi condivisi.
Il contesto più ampio amplifica ulteriormente queste questioni. In un momento storico peculiare, una figura come Donald Trump — il cui progetto politico ha attivamente minato le istituzioni internazionali create per salvaguardare la pace e che respinge crisi globali urgenti come il cambiamento climatico - è stata seriamente considerata come potenziale destinataria del Premio Nobel per la Pace. Questo contrasto solleva interrogativi fondamentali: cosa significa premiare la “pace” quando i principi democratici vengono applicati in modo incoerente? Come dovrebbe muoversi la comunità internazionale nel riconoscimento in un contesto in cui la legittimità morale e politica è sempre più contestata?
Inoltre, la decisione di onorare un individuo piuttosto che le innumerevoli organizzazioni che rischiano la propria incolumità per prevenire genocidi e proteggere popolazioni vulnerabili - come avviene a Gaza - rappresenta un’occasione mancata. Attori collettivi che operano in contesti difficili - ad esempio la guerra civile in Sudan, la violenza armata nella regione del Sahel e la guerra civile in Myanmar - dimostrano un impegno autentico per difendere la dignità umana e la pace.
In definitiva, il Nobel a Machado mette in evidenza una lezione cruciale: democrazia e pace sono inseparabili. Una pace autentica non può coesistere con espressioni estremiste che sminuiscono il valore intrinseco della vita umana. Né può prosperare quando gli attori progressisti difendono selettivamente la democrazia in base alla convenienza politica. In un’era di polarizzazione, la difesa dei valori democratici, la protezione dell’integrità umana e la ricerca della pace devono rimanere intrecciate, trascendendo le divisioni ideologiche. Solo insistendo su questo principio il riconoscimento internazionale della pace può andare oltre una mera convalida simbolica, trasformandosi in un reale rafforzamento dell’ideale democratico.