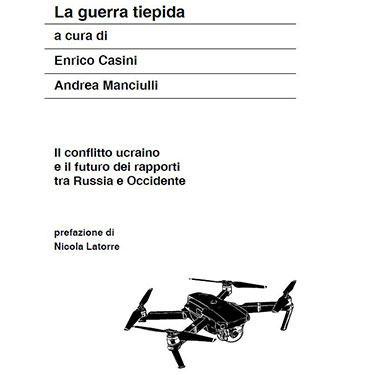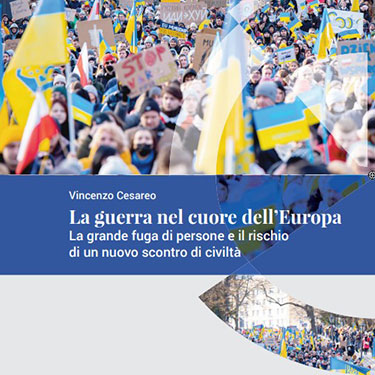Dalle questioni economiche a quelle di natura strettamente giuridica. A entrare nel merito è stato Maurizio Arcari, dell’Università di Milano Bicocca, parlando dell’uso della forza da parte di tutti gli attori coinvolti nella guerra: la Russia come stato aggressore, l’Ucraina come aggredito e la comunità internazionale nelle sue varie reazioni, e su come esso sia destinato a incidere nello scenario futuro dell’ordinamento internazionale. «Il concetto giuridico di legittima difesa ha fatto da cappello utilizzato dagli stati per giustificare l’operazione di difesa sia come legittima difesa preventiva sia come tutela degli interessi essenziali dello stato che può difendersi quando deve tutelare alcune sue prerogative».
Ecco perché, ha indicato Massimo Starita, dell’Università di Palermo, «la guerra ci mostra un nuovo assetto politico, diverso da quello egemonico degli ultimi 30 anni rivisitando da parte dell’ONU il modo di intendere il concetto di pace e di sicurezza internazionale e l’orientamento politico complessivo del Consiglio di sicurezza». Il docente ha poi analizzato gli aspetti istituzionali relativi alla natura del coinvolgimento del Consiglio di Sicurezza con il diritto di veto e dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite con le due risoluzioni di condanna dell’aggressione. Sono così emersi i limiti della difesa comune europea, il ruolo della NATO per la difesa europea, con la conseguente dipendenza da scelte funzionali ad interessi degli Stati Uniti più che dell’Europa, il riavvicinamento tra Russia e Cina.
In qualunque modo finirà questa guerra, gli scenari che ne deriveranno, interrogheranno l’Europa sul piano della sicurezza militare. «Si nota l’assenza di una difesa europea, che pare a rimorchio dell’America. È utile una maggior coerenza nelle situazioni in atto per definire nuovi modi e mezzi per migliorare le capacità militari e ottenere mandati per missioni più flessibili e un processo decisionale rapido negli aspetti militari», ha affermato Antonio Tanca, docente di European Union Common and Security Defence Policy all’Università Milano Bicocca.