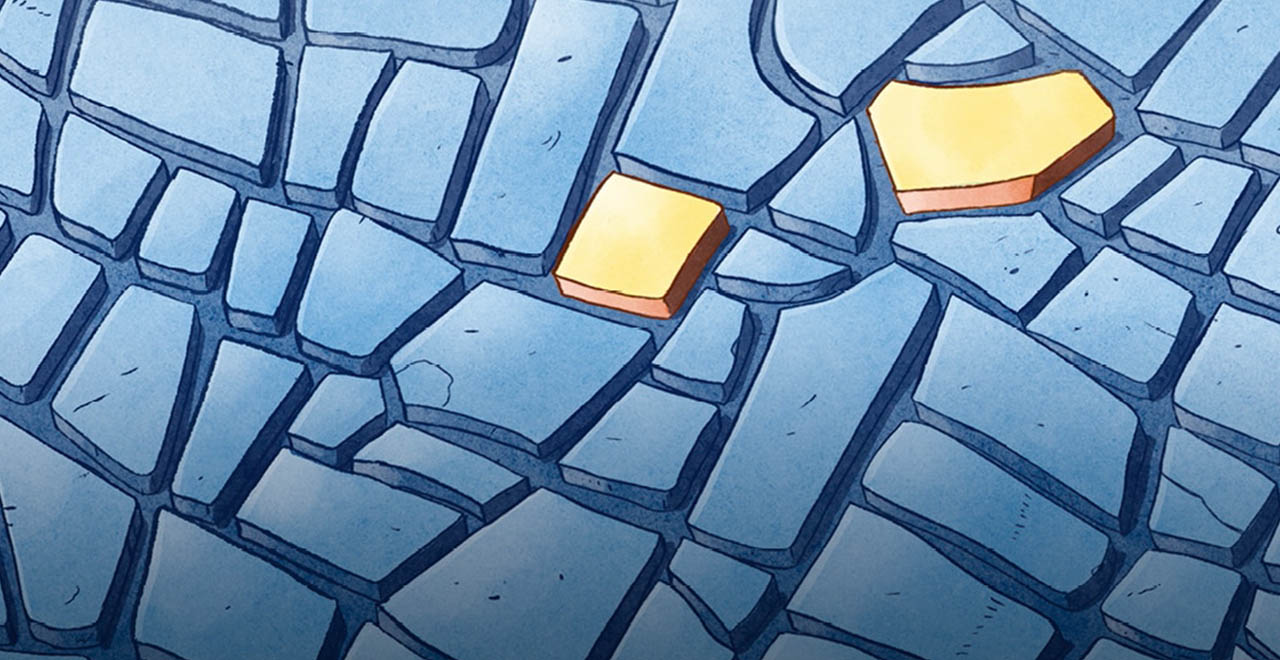«Anche nella critica non dobbiamo confondere giusti ed empi: non tutti i musulmani sono Hamas, non tutti gli ebrei sono la guerra». Verso la fine ha fatto irruzione l’attualità più drammatica nell’intervento di Joseph Weiler al Meeting di Rimini. Il giurista, professore alla NYU Law School e Senior Fellow ad Harvard, è una presenza fissa alla manifestazione, «un fratello maggiore da ascoltare con gratitudine», come ha sottolineato nel presentarlo all’incontro “Edifici, antichi e moderni, nella narrazione biblica” (solo in streaming) Stefano Alberto, docente di Teologia all’Università Cattolica del Sacro Cuore, che da anni dialoga con lui.
La frase dello studioso ha preso spunto dal famoso passo di Genesi in cui Abramo intercede per Sodoma, chiedendo a Dio: «Davvero sterminerai il giusto con l’empio?». Commentando quel versetto Weiler ha voluto lanciare un monito, in tempi in cui il conflitto in Medio Oriente rischia di alimentare nuovi germi di odio: «La giustizia di Abramo è il criterio per giudicare anche oggi: criticare un governo è legittimo; odiare un popolo è vergognoso».
Nel suo discorso il professore ha rintracciato i passaggi nei quali nella Bibbia si menziona l’opera costruttrice dell’uomo. Ha ricordato che il primo riferimento non è la Torre di Babele ma è legato alla figura di Caino: è lui, dopo aver assassinato il fratello Abele, a costruire la prima città. Il luogo dove fioriranno le arti e i mestieri: l’allevamento, la musica, la metallurgia. Eppure, costruire non è di per sé un peccato, benché nasca da un crimine orrendo come un fratricidio. «La prima lezione è che la città e gli edifici non sono contrari al piano di Dio. Sono strumenti attraverso cui l’uomo partecipa all’opera creatrice», ha osservato Weiler.
Sotto questa luce, va interpretato il racconto della Torre di Babele. Dio disperde il progetto da un lato perché, secondo Weiler, «quegli uomini volevano fermarsi in un solo luogo, contro il comando divino di riempire la terra», dall’altro perché «volevano “farsi un nome” senza menzionare Dio». Un peccato di arroganza che oggi si ripete, secondo lo studioso, nella «pretesa della scienza di dare tutte le risposte alla condizione umana».
Nella narrazione biblica occupa molto spazio (ben sei capitoli) un altro edificio: il Tempio di Gerusalemme. Eppure, sottolinea il giurista, «il Tempio non è la casa di Dio, ma il segno che Dio vuole abitare nel cuore del suo popolo». Anche i profeti, come Geremia, ne hanno denunciato l’abuso: «Non fate del Tempio un rifugio ipocrita. La vera fedeltà non è nel luogo, ma nell’agire con giustizia e diritto».
Questa posizione diventa ancora più radicale con il cristianesimo. Quando Gesù scaccia i mercanti dal tempio, annuncia la distruzione del santuario, per ritrovare una più autentica relazione con Dio. Nondimeno i cristiani costruiranno nei secoli magnifiche cattedrali. Ma anche in questo caso la contraddizione è solo apparente. «Gli edifici sacri – ha risposto Weiler – hanno un valore spirituale: aiutano la comunità a riconoscersi, custodiscono la bellezza, ricordano che il vero Re non è terreno ma divino. La bellezza non è estetica, è dono del Signore». Insomma, i mattoni delle grandi chiese sono segno di quei mattoni con cui è costruita in cielo la casa del Signore, sono il simbolo della fedeltà a Dio: quei mattoni nuovi con cui si costruisce nei luoghi deserti citati dal poeta T.S. Eliot, e che hanno suggerito il titolo a questa edizione del Meeting di Rimini.