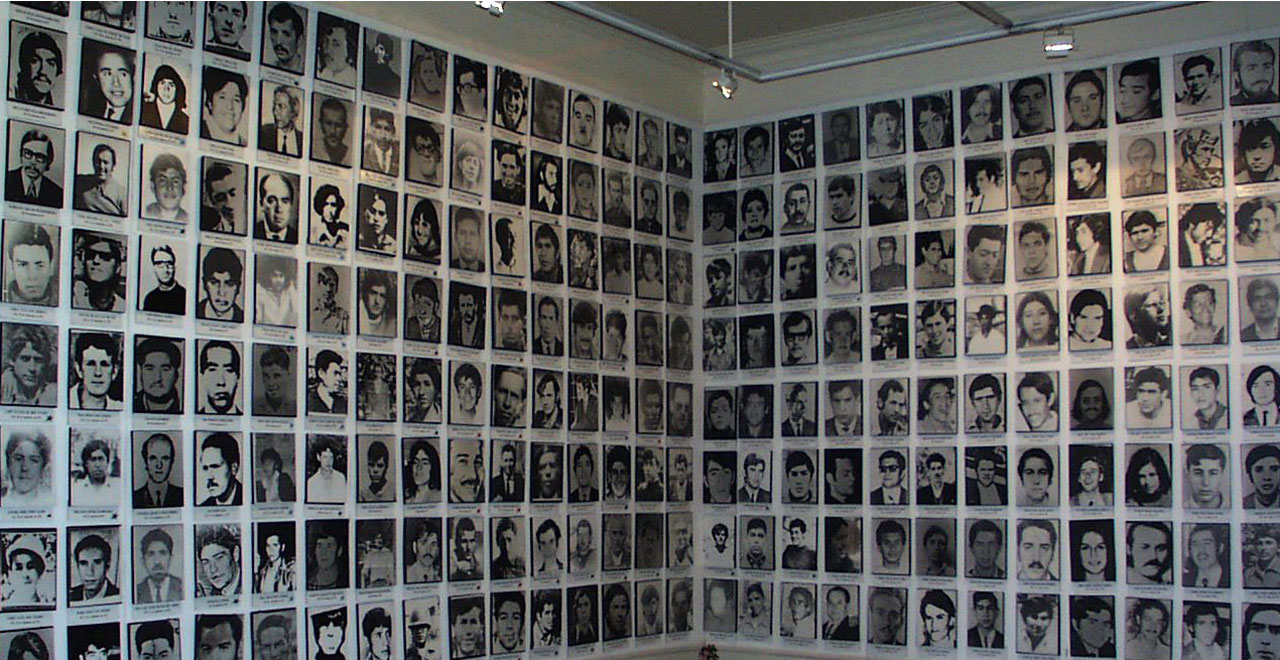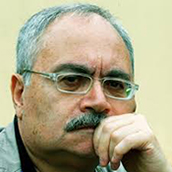La storia ritorna, tende a ripetersi perché gli esseri umani, nonostante i secoli, rivivono le loro più grandi virtù e anche i loro più grandi difetti. Ammirano le piramidi d’Egitto e, quando tracciano una lunga linea retta sulla carta geografica, ripiegano sullo splendore classico di Tikal o Chichén Itzá, dei Maya, o sulla perfezione urbanistica di Tenochtitlán, degli Aztechi. Come non rimanere stupefatti dal colonnato del Bernini in Piazza San Pietro? Uno dice: umanità. Sul lato oscuro: Cesare è stupefatto quando vede il suo figlioccio tra i cospiratori; Goebbels mette la mano sulla pistola quando sente la parola "cultura"; i campi di concentramento e i gulag non possono essere giustificati a metà del XX secolo. C’è un lato della storia pieno di arte e poesia; ce n’è un altro, pieno di ignominia. Si pensa sempre che si vorrebbe essere dalla parte giusta, accanto agli eroi e ai santi. Primo Levi ci avverte che non è sempre così. Non tutto è bianco o nero. C’è una “zona grigia”: quella dove ci sono gli indifferenti, gli approfittatori, i dissimulatori, i silenziosi, i burocrati, quelli che dicono "non sono stato io, me l’hanno ordinato" e quella zona è ampia e vasta, ospita i vigliacchi che sanno di far parte di una macchina di morte e mentono a se stessi, dissimulano, chiudono un occhio e anche l’altro, quelli che non intervengono quando dovrebbero, quelli che obbediscono quando dovrebbero disobbedire. Quelli che dovrebbero esclamare, con Bartleby lo scrivano: "Preferisco non farlo".
Il tempo ci costringe a riflettere, a ricordare senza nostalgia. Tale riflessione inizia con quel Paese situato alla fine del mondo, che inizia nel deserto andino e finisce per toccare i feroci mari del sud, terrore dei marinai e spavento dei bucanieri, dove due mari si incontrano, dove i continenti finiscono e toccano le gelide acque dell’Antartide. Parliamo del Cile, una sottile striscia verticale che, guarda caso, ha la forma della pianta da cui prende il nome. Tutto è unico in Cile: il suo dolce modo di parlare lo spagnolo, la varietà del suo territorio, le sue ricche miniere d’oro, d’argento e di rame, la sua gente resistente e allegra, la sua potente letteratura. Il Cile si trova dall’altra parte delle Ande, se lo si guarda dall’Argentina. Ed è come se quella spina dorsale che sale verso il cielo creasse un altro mondo, un universo a parte. Infatti, insieme all’Uruguay e al Costa Rica, il Cile è stato per molti anni un laboratorio di democrazia, un’eccellenza nella turbolenta storia dell’America Latina. Dopo l’indipendenza dalla Spagna, non mancò un dittatore pittoresco, una sorta di requisito per essere latinoamericani: Don Diego Portales, che costrinse la popolazione a fare ginnastica alle 5 del mattino. Ma dopo quell’obbrobrio, la vita politica proseguì in una democrazia pacifica, con l’eterna discussione tra liberali e conservatori. Questo per dire che i cileni non avevano la cattiva abitudine di molti loro vicini latinoamericani: quella di svegliarsi ogni due giorni con un colpo di Stato militare.