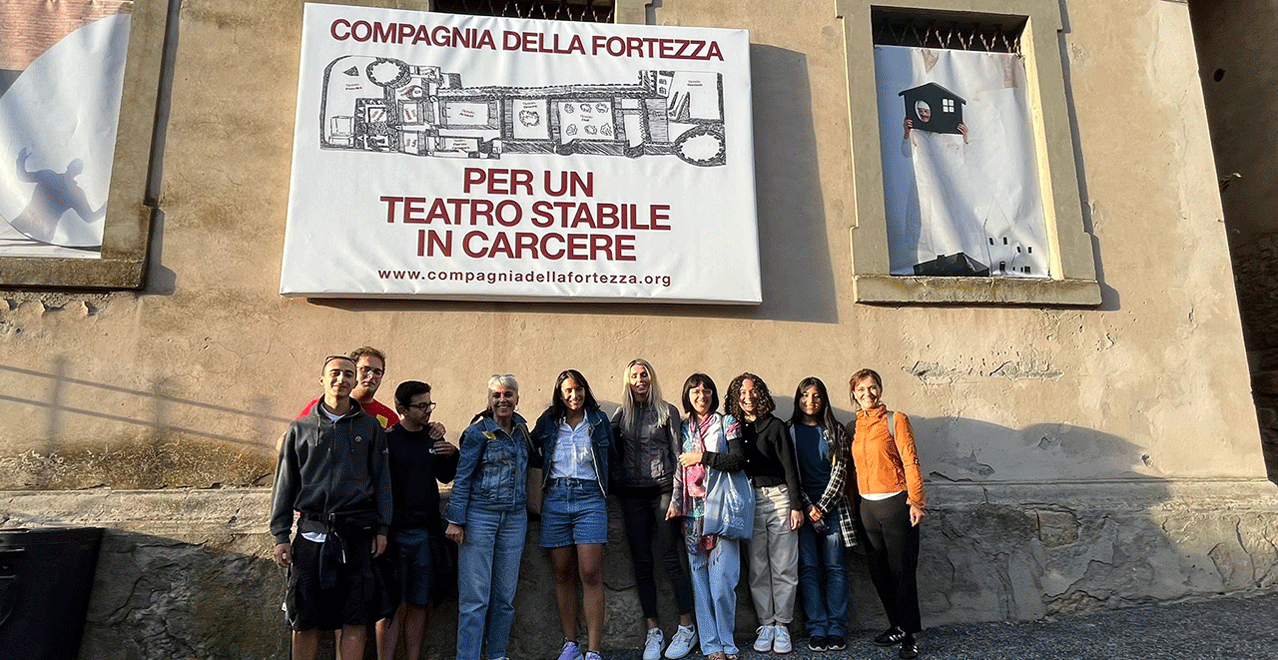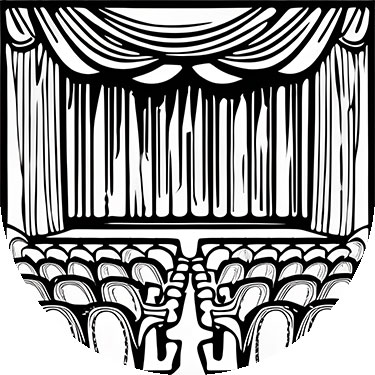Estate. Il tempo del disimpegno, delle pause necessarie, delle agende che finalmente si svuotano.
Eppure, proprio questa parentesi può trasformarsi in un’opportunità preziosa di esplorazione e di scoperta, capace di allargare lo sguardo ben oltre i confini consueti dell’aula universitaria. È quanto hanno vissuto un gruppo di studenti e studentesse del corso di laurea in Scienze della formazione, che, accompagnati dalla professoressa Elisabetta Musi, hanno trascorso due intense giornate – il 28 e 29 luglio – nella Casa di reclusione di Volterra (PI) per assistere agli spettacoli teatrali della “Compagnia della Fortezza”.
Qui, da oltre trent’anni, il regista Armando Punzo sceglie di fare teatro in carcere, intrecciando disciplina, fiducia, parola e presenza con uomini che, prima di entrare in scena, non avevano mai nemmeno immaginato di farlo. Un lavoro che non nasce da un intento educativo dichiarato – Punzo lo precisa con fermezza –, ma che ha in sé una evidente forza trasformativa.
«Punzo» spiega la professoressa Musi «propone un teatro che nasce da una scelta di vita, capace di testimoniare una fiducia autentica nell’essere umano. Lavorare con i detenuti significa, per lui, costruire uno spazio di disciplina, attenzione, ascolto e responsabilità, capace di restituire dignità a chi non si è mai avvicinato al mondo del teatro. È un processo trasformativo profondo, pur non avendo una finalità dichiaratamente educativa».
Quest’anno la Compagnia ha portato in scena due opere particolarmente significative: Cenerentola, una rilettura tutt’altro che convenzionale del celebre racconto, che trascina lo spettatore in un universo filosofico e interrogativo, governato da un principio vitale che genera vita; e Fame, tratto dall’omonimo romanzo di Knut Hamsun, che porta sul palco l’esperienza di un desiderio irrequieto e bruciante.
Alla fine degli spettacoli, gli studenti hanno incontrato la costumista Emanuela Dall’Aglio e, soprattutto, con Armando Punzo, che ha condiviso le riflessioni maturate negli ultimi anni di lavoro: «Abbiamo dato vita – ha raccontato – a un soggetto simbolico che non accetta l’esistente. Il suo compito è spingerci altrove, verso orizzonti nuovi. La prigione reale diventa così metafora di una prigione più grande, in cui tutti siamo rinchiusi e da cui possiamo, tuttavia, liberarci».
«È stata un’esperienza straniante, e proprio per questo profondamente formativa» conclude la professoressa Musi. «Ciò che destabilizza – lo abbiamo sentito tutte e tutti – ci richiama alla nostra responsabilità di soggetti morali: dare voce a ciò che resta fuori, a quel mondo che – come dice Punzo – “urla la sua presenza agonizzante oltre le mura del carcere”, mentre una parte della società resta silenziosa, quasi addormentata».
«Da Volterra siamo tornati con un interrogativo che non si lascia accantonare facilmente: cosa significa, oggi, liberarsi dalle nostre prigioni interiori?».